Macerata. Henri Matisse e la Cappella di Vence, mostra a Palazzo Ricci
Henri Matisse (1869-1954), uno dei maggiori artisti francesi, negli ultimi anni di vita si dedicò all’opera che egli stesso definì “il mio capolavoro”, ovvero la “Chapelle du Rosaire” del Convento di suore domenicane di Lacordaire a Vence, cittadina nel sud della Francia, non lontano da Nizza. Si tratta di un’opera d’arte totale, nel senso che Matisse si occupa della progettazione di ogni singolo aspetto: l’architettura, le vetrate con il tema dell’Albero della Vita, le ceramiche con le immagini della Vergine con il Bambino, la Via Crucis, l’altare con il Crocifisso e i candelabri, la porta del confessionale, gli stalli del coro, tutti gli arredi e i paramenti liturgici. Lo fa su invito di una giovane novizia di quel convento (all’epoca privo di una cappella), Soeur Jaques-Marie, vissuta fino al 2005
Benché già famoso, per Matisse si tratta di una vera e propria sfida e nel 1949 inizia a lavorare al progetto. Nell’ottobre del 1950, dopo aver completato i lavori della Cappella, egli si dedica alla progettazione dei paramenti liturgici e progetta sei casule, una per ciascuno dei colori tradizionali di base prescritti per i diversi tempi dell’anno liturgico: bianco, rosso, verde, nero, viola e rosa. Dopo un confronto con il frate domenicano padre Marie-Alain Couturier (1897-1954), suo amico e consigliere, Matisse decide di realizzare le casule riprendendo la forma utilizzata nel Medioevo, ampia e tagliata a mezzaluna, con il retro un po’ più lungo del davanti, di circa 2 metri di larghezza e 1,30 di lunghezza. Una veste che avvolge il corpo del celebrante, sostenendo e amplificando il gesto liturgico. Per arrivare al progetto definitivo egli realizzò più di venti studi diversi, combinando i colori di base con stelle, croci, foglie di palma, fiamme di luce, corolle di fiori. “Sembrano farfalle in volo” avrebbe detto Pablo Picasso entrando una volta nello studio di Matisse alle cui pareti erano appesi i bozzetti.
Prima di realizzare le casule definitive in popeline di seta con effetto velluto, Matisse volle controllare la loro funzionalità e qualità estetica. Per questo fece confezionare dalle suore domenicane di Crépieux près de Lyon, specializzate in abiti liturgici, quattro casule in poliestere (una bianca, una nera, una rossa ed una verde), quale prova di cucitura finale.
Questa serie di casule (mai indossata) è stata donata nel 1977 dalle suore domenicane di Lacordaire ai Musei Vaticani ed ora è per la prima volta visibile al pubblico a Macerata in una mostra allestita a Palazzo Ricci, inaugurata alla presenza del cardinale Gianfranco Ravasi.
L’esposizione, “Henri Matisse e la cappella di Vence”, a cura di Micol Forti, è stata promossa ed organizzata in collaborazione tra Diocesi di Macerata, Musei Vaticani e Fondazione Carima. Oltre alla quattro casule, esposte in speciali teche, sono presenti nella mostra altri elementi del corredo, come i veli copricalice e le stole, tre litografie, i bozzetti preparatori per il pannello della Vergine con il Bambino, il bozzetto in bronzo e ottone della grande croce che svetta sul tetto della Cappella, e copia anastatica di parte della corrispondenza che in quel periodo si scambiarono Matisse e la Madre Superiora del Convento, Mère Agnès.
È stato osservato come l’intera opera realizzata da Matisse per la “Cappella di Vence” abbia contribuito alla successiva riforma liturgica attuata dalla Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Oltre ai paramenti liturgici, l’esempio più evidente dell’influsso esercitato dal progetto di Matisse sulla riforma post conciliare è stata la scelta dell’artista di posizionare l’altare della Cappella rivolto verso i fedeli, cioè come verrà stabilito dalla riforma degli anni Sessanta. “La storia della Cappella di Vence – ha scritto monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata – è una bellissima storia di dialogo, confronto e collaborazione tra il mondo dell’arte e il mondo della fede cattolica, vissuta in un tempo particolarmente creativo, come furono gli anni del pre-Concilio, del Concilio e del post-Concilio”.
La mostra rimarrà aperta ad ingresso libero fino al 28 settembre ed è visitabile negli stessi orari del Museo di Palazzo Ricci: dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19, la domenica e i giorni festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.
© Alessandro Feliziani / Orizzonti della Marca
(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA n. 31 del 9 agosto 2025)

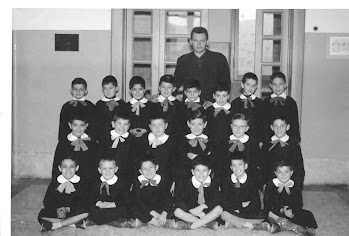


Commenti
Posta un commento