Medioevo in val di Chienti
In un suo recente libro, il giornalista Marco Brando esorta i propri colleghi a sbarazzarsi di citazioni stereotipate delle parole “Medioevo” e “medievale” utilizzate in chiave riprovevole. Classificare ogni atto o vicenda negativa come “ritorno al Medioevo” o “pratica medievale” contribuisce a perpetuare un cliché che non rende giustizia – come asserisce l’autore di “Medi@evo, l’età di mezzo nei media italiani” – a quei secoli, tra Classicismo e Rinascimento, tutt’altro che negativi, né affatto banali.
Chi si vuole rendere conto, ad esempio, della ricchezza culturale che il Medioevo ci ha tramandato, è sufficiente leggere l’ultimo numero di “Studi Maceratesi”, uscito a fine 2024, in cui sono pubblicati gli atti del cinquantottesimo convegno annuale del Centro Studi Storici Maceratesi, svoltosi nel novembre dell’anno precedente a Montecosaro sul tema “Il Maceratese e le Marche centro-meridionali tra impero e papato (secc.X-XII)”.
Come ricorda nella presentazione del volume il presidente del Centro Studi, Alberto Meriggi, un convegno interamente incentrato sull’Età medievale mancava da quindici anni nelle attività dell’associazione e, nel ritornare ad occuparsi di tale periodo storico, la scelta di Montecosaro non è stata casuale. Come molti altri centri della provincia maceratese, Montecosaro ebbe origine e si sviluppò proprio nei due secoli cui il convegno ha fatto riferimento ed oggi deve la sua principale attrazione culturale e turistica alla Chiesa dell’Annunziata, più conosciuta con il nome di Santa Maria a Piè di Chienti (nella foto), il cui nucleo originario, costituito da un monastero dipendente dall’abbazia di Farfa, risalirebbe proprio al decimo secolo. A tale collegamento con la terra Sabina è dedicato il saggio di Maria Teresa Gigliozzi, che vede nelle forme architettoniche di Santa Maria a Piè di Chienti un “emblematico manifesto di riforma del monachesimo farfense”, mentre Francesco D’Angelo, nelle pagine che seguono, ricostruisce il graduale dissolvimento della giurisdizione temporale farfense nelle Marche in conseguenza della incorporazione dell’abbazia nello Stato della Chiesa.
L’archeologo Enzo Catani offre una nuova lettura, “facilitata da un recente intervento di restauro del manufatto sacro”, del testo graffito presente sul coperchio del reliquiario rinvenuto sotto l’altare della Chiesa dell’Annunziata. Nel volume è anche presente un contributo a livello storico-archeologico e geologico riguardante l’intero comprensorio relativo a Santa Maria a Piè di Chienti, frutto di un lavoro di ricerca interuniversitario (Unicam e Unimc) cui hanno lavorato Gilberto Pambianchi, Piero Farabollini, Emanuela Stortoni, Domenico Aringoli e Marco Materazzi.
Un contributo prezioso dato agli studi storici dal convegno di Montecosaro, perché in modo puntuale e documentato ha messo una “pietra tombale” alla inverosimile tesi secondo cui l’antica Aquisgrana sarebbe da identificarsi nella vallata del Chienti, è quello di Florian Hartmann. Lo studioso tedesco, che è componente del Comitato scientifico dell’Istituto Storico Germanico di Roma e del Comitato scientifico del Centro Studi Longobardi, riporta documenti da cui emerge inequivocabilmente che la località di Aquisgrana era non lontana da Colonia e lì si trovava il cuore del regno carolingio, punto di riferimento istituzionale per Carlo Magno e per tutti gli imperatori che hanno regnato dopo di lui.
A San Claudio al Chienti sono dedicati anche due contributi di Hildegard Sahler e Furio Cappelli. La studiosa tedesca si sofferma sul significato della cappella doppia, che sta ad indicare la duplice funzione dell’edificio: quella di pieve (parte inferiore) e quella di cappella palatina (parte superiore), mentre il medievalista ascolano si occupa della doppia torre, collegando il caso di San Claudio ad altri esempi dell’edilizia religiosa del Medioevo europeo.
Di altre due abbazie presenti nella vallata del Chienti si occupano Nicolangelo D’Acunto (Santa Croce al Chienti) e Pier Francesco Pistilli (Chiaravalle di Fiastra), mentre Francesco Pirani ricostruisce le vicende che alla fine del sec. XI condussero alla creazione della “Marca di Ancona” e Umberto Moscatelli si sofferma sui progressi della ricerca archeologica marchigiana riferita al periodo carolingio.
Unico contributo riferito ad aspetti non legati al territorio marchigiano è quello di Giovanni Collamati, la cui ricerca storica riguarda l’uso del titolo imperiale nei contesti dell’Inghilterra anglosassone e del Regno di Austria-Leon del X secolo.
Il volume si apre con l’intervento di Tommaso di Carpera Falconieri, incentrato sul ruolo strategico che le Marche, per la loro posizione geografica, ebbero sia per l’Imperatore, sia per il Papa, mentre nelle pagine conclusive Stefano Cotroneo compie una panoramica delle abbazie presenti nel Maceratese, soffermandosi sulla loro importante funzione di centri economici e di cultura.
© Alessandro Feliziani / Orizzonti delle Marca
Aa.Vv. Il Maceratese e le Marche centro-meridionali tra impero e papato (Secc. X-XII), Centro Studi Storici Maceratesi, Macerata 2024, pp. 302, s.i.p.
(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA n. 10 di sabato 15 marzo 2025)

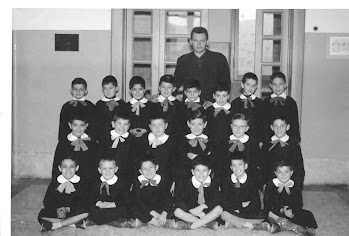


Commenti
Posta un commento