Infanzia abbandonata nelle Marche.
S. Montecchiani, Per una storia dell’assistenza ed educazione dell’infanzia abbandonata nelle Marche, Eum, Macerata 2021, pp. 192, euro 18.
© Oggi notizie di neonati abbandonati all’interno di una chiesa o nell’aiuola di un giardino o in altri posti pubblici ben frequentati sono, per fortuna, sempre più rare e, proprio per questo, finiscono per avere una grande eco nei giornali e nei notiziari televisivi. Un tempo, invece, fino a gran parte del secolo scorso e soprattutto nei secoli precedente, tali abbandoni erano frequentissimi e non destavano alcun scalpore. Per secoli, fino alla sua abolizione avvenuta per legge nel 1923, quasi tutti i monasteri avevano la famosa “ruota” dove si poteva lasciare il neonato nella certezza che qualcuno si sarebbe preso cura di lui.
Tra quelle primordiali forme di abbandono dei neonati e le odierne istituzioni o garanzie a tutela dei minori e del diritto alle donne di partorire in anonimato, potendo essere assistite in ospedale e non essere perseguite se decidono di non riconoscere il figlio, c’è stata una lunga evoluzione in cui all’assistenza dell’infanzia abbandonata si è unita l’educazione dei bambini “esposti”.
A questo tema è dedicato un volume con il quale la Eum, casa editrice dell’università di Macerata, ha dato alle stampe uno studio di Sofia Montecchiani, giovane dottoranda in scienze umane presso il dipartimento di Scienze della formazione dello stesso ateneo maceratese. Il saggio, che costituisce il diciannovesimo titolo della collana “Biblioteca di storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia”, diretta da Roberto Sani ed Anna Ascenzi, approfondisce il drammatico problema dell’esposizione infantile nelle Marche e il complesso dibattito culturale e politico che portò nel 1838 all’istituzione del brefotrofio di Osimo (consorziato con quello di Cingoli).
L’istituzione osimana fu fortemente voluta dal vescovo locale, cardinale Giovanni Antonio Benvenuti, il quale ebbe il supporto di diverse personalità laiche, tra le quali si distinse il conte maceratese Leopardo Armaroli.
Nel contesto dello Stato pontificio, il brefotrofio di Osimo rappresentò l’emblema di una allora moderna concezione di educazione e il “risultato di una proficua collaborazione tra i principi cardine della morale cristiana e quelli laici dell’impegno etico-civile”.
L’autrice pone in evidenza come in passato, proprio grazie all’apertura dei brefotrofi e altre similari istituzioni, si sia sviluppato un cruciale collegamento tra assistenza ed educazione nei confronti della prima infanzia.
Il volume, oltre ad un utile indice dei nomi, offre un’ampia appendice documentaria, dove figura, tra l’altro, un circostanziato rapporto del conte Armaroli in merito alla costituzione dei due brefotrofi consorziati di Cingoli e Osimo ed il regolamento per l’amministrazione degli stessi.
© Alessandro Feliziani / Orizzonti della Marca
(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA del 3 settembre 2022 n. 32)

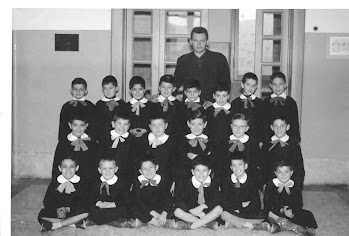


Commenti
Posta un commento