Quando al referendum Camerino si scoprì divorzista.
© In queste settimane stampa e Tv hanno ricordato con numerosi servizi giornalistici i cinquant’anni della legge che introdusse il divorzio nella legislazione italiana. Le vivaci polemiche di allora sono ricomparse, per fortuna in maniera molto limitata, anche dopo mezzo secolo e la miccia si è accesa anche nelle Marche. La deputata pesarese Alessia Morani (attualmente sottosegretario al ministero per lo sviluppo economico) e l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, hanno pubblicamente criticato l’assessore alla cultura della regione, Giorgia Latini, che in un’intervista al TgMarche ha dichiarato di essere da “sempre contraria all’aborto” e di voler far valere la propria posizione anche nel governo regionale. La bufera si è subito spenta, ma per un paio di giorni ha richiamato alla memoria il dibattito che tra gli anni ’60 e ’70 aveva animato l’intera società italiana.
La legge sul divorzio fu approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati poco dopo le 5 del mattino di martedì 1 dicembre 1970, dopo un’ennesima ed ultima seduta iniziata il giorno precedente e durata ininterrottamente 18 ore. A favore votarono compatti i deputati di un fronte politico trasversale che andava dalla sinistra alla destra liberale. Promulgata nelle ore successive dal presidente della Repubblica, Saragat, la legge (n. 898) fu pubblicata due giorni dopo sulla Gazzetta ufficiale. Si chiudeva così un lungo scontro politico in Parlamento, ma se ne apriva uno ancora più aspro nel paese. Uno scontro che coinvolse per anni l’intera società. La DC, allora partito di maggioranza relativa, che insieme al Msi aveva votato contro alla Camera, così come già in precedenza al Senato, ritenendo che il voto parlamentare non rispecchiasse la volontà della maggioranza degli italiani, promosse – con l’appoggio di diversi movimenti cattolici – un referendum abrogativo della legge.
Era la prima volta che l’istituto referendario, contemplato dalla Costituzione, veniva utilizzato nella storia repubblicana.
Per milioni di italiani si trattava di una novità assoluta, mentre molti dei più anziani si trovarono in qualche modo a rivivere il clima del referendum istituzionale del 1946. Sta di fatto che domenica 12 maggio 1974 gli elettori risposero in massa alla “chiamate alle urne”. Con l’88% di votanti (93% nel maceratese) quella del 1974 è rimasta la consultazione referendaria più partecipata. Il risultato diede torto ai promotori del referendum. Il quesito referendario chiedeva agli elettori se volessero o meno abrogare la legge 898/70 e quasi il 60% dei votanti rispose NO, pronunciandosi così per il mantenimento della legge. Pur con percentuali diverse, i favorevoli al divorzio risultarono maggioranza in gran parte delle regioni, comprese le Marche, dove Macerata fu l’unica delle allora quattro province ad esprimersi con una maggioranza diversa. I contrari al divorzio e quindi favorevoli all’abrogazione della legge furono nel maceratese 93.453 contro 91.264 “divorzisti”. Uno scarto di poco più di duemila voti, corrispondente ad una percentuale veramente minima (SI 50,6%, NO 49,4). Il SI (contrari al divorzio) fu maggioranza in 45 dei 57 comuni. Le percentuali maggiori si registrarono a Monte San Martino (80%), Gualdo (69%), Castelsantangelo sul Nera (68%), Ussita (65%), Sarnano (64%), Visso (63%). I favorevoli al mantenimento della legge sul divorzio prevalsero nei restanti dodici comuni, tra cui Camerino (SI, 45,8% – NO 54,2%) che, tra tutti i comuni della provincia, fu quello a destare per molti maggiore sorpresa. Non per Il Resto del Carlino, che titolava: Il NO di Camerino era previsto, aggiungendo: Non è stata una sconfitta della DC. Il risultato rientra nelle tradizioni politiche e culturale della città camerte.
Altri comuni in cui gli elettori si espressero favorevolmente al mantenimento della legge sul divorzio furono Esanatoglia (70%), Pioraco (62%), Matelica e Tolentino (61%), Muccia (56%) e con percentuali minori: Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Civitanova, Porto Recanati, Potenza Picena.
Nell’infuocata campagna elettorale trovò ampiamente posto anche una polemica sul sistema di voto. Va ricordato, infatti, che il referendum sulle leggi ordinarie non è propositivo, ma abrogativo. Non si vota cioè a favore di una determinata legge, ma solo a favore, o meno, della sua eventuale abrogazione. Quindi, nel 1974 coloro che erano contrari al divorzio dovevano votare SI (indicando con ciò di essere favorevole all’abrogazione della legge) e chi invece la legge sul divorzio voleva mantenerla doveva votare NO. All’epoca per tanti italiani - specie per i più anziani - il solo temine “abrogazione” rappresentava una parola difficile da comprendere e di conseguenza anche il meccanismo del reale significato referendario del SI e del NO. Questo fatto diede spunto per qualche tempo a supposizioni sulla reale posizione degli italiani in merito al divorzio in quei primi anni Settanta del secolo scorso.
© Alessandro Feliziani / Orizzonti della Marca
(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA n. 49 del 19 dicembre 2020)

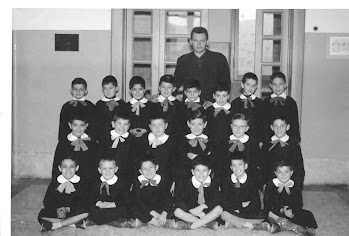


Commenti
Posta un commento