Ma i borghi non intravedono la loro salvezza...
© Il più recente rapporto sulla situazione sociale del Paese ci ha detto che il 69% degli italiani guarda al futuro con grande incertezza e il 17% è del tutto pessimista, mentre e solo il 14% si dice ottimista. Se quell’indagine non fosse state realizzata dal Censis a livello nazionale, si sarebbe potuto supporre che gli intervistati fossero stati tutti abitanti delle zone terremotate. Invece no, la sfiducia è generalizzata e il principale imputato – lo dice lo stesso Censis – è la politica, che sembra oggi incapace di offrire prospettive. Più di tre italiani su quattro, infatti, ha dichiarato di non avere fiducia nei partiti e la causa più che la loro quotidiana litigiosità sta nella incapacità di adottare provvedimenti tali da incidere in modo efficace su una crescita sociale ed economica in grado di offrire prospettive a lungo termine.
Si è detto che nonostante tutto l’Italia resta un paese “eccellente” sotto diversi profili e questo è sicuramente merito degli stessi italiani. Del resto gran parte di ciò che è stato realizzato nelle aree terremotate in questi tre anni è frutto di molte iniziative private e delle più svariate azioni di solidarietà.
Anche quelle poche leggi ampiamente condivise e condivisibili che il Parlamento riesce a produrre, troppo spesso restano al palo per una incapacità di dare concreta attuazione ai buoni propositi. Si prenda ad esempio la legge comunemente chiamata “salva borghi”, volta a “sostenere e valorizzare i piccoli comuni, nonché a riqualificare e recuperare i loro centri storici” della quale abbiamo scritto a suo tempo su Orizzonti della Marca (n. 37 del 7 ottobre 2017).
Frutto di due distinti progetti presentati alla Camera tra il 2013 e il 2014 da Ermete Realacci (Pd) e dalla deputata marchigiana Patrizia Terzoni (M5S), la legge è stata approvata nell’autunno del 2017 e salutata nell’occasione come il primo atto per invertire il trend dello spopolamento che caratterizza i paesi montani e le aree più disagiate o economicamente fragili. Ebbene, dopo due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore, la legge non ha di fatto esperito alcun effetto, nonostante diversi fondi stanziati sin dal 2018. La causa: mancano i decreti attuativi che il governo e i singoli ministeri debbono emanare per disciplinare le concrete modalità di intervento indicate dalla legge stessa, tra cui: trasporti e istruzione nelle aree montane, possibilità di istituire centri multifunzionali per una ampia serie di servizi, recupero di zone di particolare pregio nei centri storici, realizzazione di alberghi diffusi, misure per contrastare l’abbandono di terreni ed edifici in disuso, sostegno alla commercializzazione e consumo di prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta.
Più di un anno fa duecento sindaci di tutta Italia, tra i quali anche i primi cittadini di Cessapalombo e Pieve Torina, avevano firmato un appello al governo per accelerare i tempi. In quel documento si sottolineava la necessità che i piccoli comuni (la loro superficie copre il 55% del territorio nazionale e il 17% della popolazione italiana) “inizino a vedere le ricadute concrete di una legge promulgata a loro difesa”. Da allora è stato emanato solo un decreto che consente ai comuni con meno di 3.500 abitanti di accedere ai finanziamenti (massimo 200 mila euro a progetto) per manutenzione di strade ed edifici pubblici. Ben poca cosa di fronte ai molteplici proponimenti della legge.
È proprio questa incapacità di dare concretezza alle buone intenzioni a prestare il fianco al crescente sentimento di sfiducia tra la gente. A chi dare la colpa di ciò? Sicuramente alla sempre più aggrovigliata macchina burocratica, ma in parte anche al farraginoso sistema amministrativo con il quale la volontà politica deve manifestarsi.
Per giunta, a volte, sembra che alcuni regolamenti, anziché agevolare i residenti nei territori montani, contribuiscano ad avvilire chi con coraggio intraprende attività economiche che, valorizzando la montagna, ne frenano anche lo spopolamento. Un caso tipico è quello accaduto lo scorso anno a due allevatori poco più che trentenni di Ussita, i quali sono stati multati ben tre volte nell’arco di poche settimane perché alcuni loro cavalli tenuti allo stato brado avevano “sconfinato” in terreni a quote superiori ai mille metri di altitudine.
Non sono certo questi i provvedimenti – per quanto possano anche essere blande le sanzioni – in grado di incentivare coloro che vivono in montagna a rimanere e continuare ad essere custodi del patrimonio naturale, garantendo la qualità delle filiere produttive legate alle produzioni agrosilvopastorali.
© Alessandro Feliziani / Orizzonti della Marca
(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA n. 6 del 15 febbraio 2020)

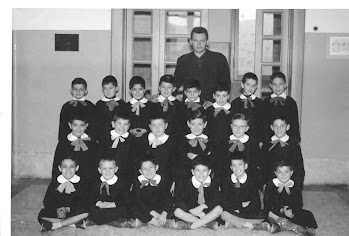


Commenti
Posta un commento