Un libro può salvarci la vita, così come può distruggercela
INTERVISTA a Giulia Ciarapica, blogger e critica letteraria, che all’Università di Macerata, dove si è laureata, ha presentato il #TalkingBook. Oltre a parlare di questo originale sistema di recensire libri da lei introdotto nel proprio blog “Chez Giulia”, ha indicato agli studenti i “ferri del mestiere” e lanciato anche qualche frecciata a quei colleghi che si affidano troppo alla “quarta di copertina” (testo pubblicato su Cronache Maceratesi. it il 19 marzo 2017)
C’erano una volta la Terza pagina e l’elzeviro. Detto così, può sembrare l’inizio di una favola, ma non lo è. Terza pagina ed elzeviro sono stati per molto tempo, infatti, i luoghi deputati della cultura e della critica letteraria sui giornali. Oggi che la Terza pagina non si può più chiamare con questo nome – e non solo perché non la troviamo più in quel determinato ordine della foliazione – l’elzeviro compare raramente nei giornali. Nello stesso tempo la critica letteraria risponde sempre più a logiche del mercato editoriale.
Per fortuna ci sono i blog letterari indipendenti e coloro che amano i libri seguono con attenzione queste pagine virtuali sul web. Sembrerebbe un controsenso: eppure, per conoscere cosa valga la pena acquistare per trascorrere qualche ora di buona lettura, chi è abituato a leggere libri di carta si affida ai blog. In particolare a quelli di critici letterari indipendenti che fanno le pulci alle migliaia di libri “sfornati” ogni mese dalle case editrici. E qui ci troviamo di fronte ad un altro controsenso dell’editoria: si legge sempre di meno e si stampa sempre di più. Ma questo è un discorso diverso su cui ci sarà modo di tornare.
Grazie ai blog indipendenti, dunque, la critica letteraria oggi non solo esce dalle “cordate” editoriali, ma si evolve e, per coinvolgere maggiormente il lettore, si reinventa continuamente dal punto di vista comunicativo.
L’ultima novità è il #TalkingBook, un originale modo di recensire i libri, frutto dell’intelligente creatività comunicativa di Giulia Ciarapica, una giovane blogger marchigiana (vive a Sant’Elpidio a Mare) che ha fatto della critica letteraria (scrive anche per L’Huffington Post e le pagine culturali de Il Messaggero) il suo mestiere.
A meno di tre anni dalla laurea in filologia moderna conseguita all’Università di Macerata, Giulia è tornata nelle aule dell’ateneo maceratese su invito della professoressa Marisa Borraccini, docente di storia del libro e dell’editoria. Lo ha fatto per parlare agli studenti che stanno per conseguire la laurea magistrale di come fare la critica letteraria con i moderni strumenti offerti dal web, ma soprattutto di come mettere a frutto le conoscenze che si acquisiscono negli studi per “costruirsi” poi un futuro. Sì, perché Giulia Ciarapica, subito dopo la laurea, si è data da fare per “inventarsi” un lavoro e ci è riuscita in poco tempo utilizzando appieno la sua preparazione universitaria. Da amante dei libri (ne leggeva tre o quattro al mese) è diventata una divoratrice di libri, arrivando a leggerne per lavoro tre o quattro a settimana. E dopo aver fatto le pulci ad ogni riga di ciò che legge, scrive il suo scrupoloso giudizio sul proprio blog “Chez Giulia” o per le testate giornalistiche cui collabora.
In poco tempo è arrivata ad avere nel blog oltre ventiduemila affezionati lettori che si affidano alle sue recensioni e nello stesso tempo è diventata una blogger amata da molto scrittori, come ad esempio Dacia Maraini che di Giulia Ciarapica apprezza la grande profondità di analisi critica e la libertà di giudizio. Caratteristiche, queste, che a volte la fanno anche “odiare” da altri scrittori, come ad esempio Michele Dalai il quale non ha affatto gradito la recensione del suo libro “Onora il babbuino”, scritta da Giulia “senza peli sulla penna”.
Come è stato, Giulia, questo tuo ritorno all’università di Macerata?
Devo dire molto bello e coinvolgente, tornare all’Università, ma dall’altra parte della barricata, è stato piuttosto insolito ed emozionante. L’incontro è stato, a mio avviso, ricco di spunti di riflessione e soprattutto di entusiasmo, considerando anche le domande che i ragazzi mi hanno rivolto nell’ultima parte dell’incontro.
Una domanda te la faccio subito anch’io. Cos’è di preciso questo genere di recensione da te inventato, #TalkingBook?
Si tratta di un nuovo modo di fare recensioni attraverso foto e citazioni. Non che sia diventata improvvisamente pigra e non abbia voglia di scrivere, ma sto cercando modi ulteriori per arrivare a quanti più non lettori possibile. Nell’era dei social network, nell’epoca della velocità, della rapidità, del cinguettio da 140 caratteri Twitter, occorreva un nuovo modo – immediato, breve, semplice – per comunicare, sfruttando quello che ritengo essere il social del futuro, Instagram. È lì, infatti, che pubblico i #TalkingBook, ossia le immagini delle copertine dei libri che consiglio, arricchendo la foto con le citazioni – rigorosamente scritte a mano – e con tutti gli elementi chiave della narrazione, inerenti alla trama e ai personaggi. In questo modo, con una semplice foto e qualche citazione, anche un non lettore che si imbatte per caso nel Talking Book può incuriosirsi e magari acquistare il libro.
Quali sono i segreti per gestire con successo un blog letterario?
Prima fra tutti, la pazienza. Il successo arriva con la perseveranza e tanta passione, non ci si deve aspettare “tutto e subito”, sarebbe un grave errore. Bisogna essere attenti alla grafica – non dimentichiamoci che l’occhio vuole la sua parte e non è questione sottovalutabile. Inoltre bisogna saper equilibrare serietà e simpatia, bisogna irrorare il tutto con una buona dose di ironia – e autoironia – senza dimenticare che il primo scopo è quello di parlare di cose belle, di qualità. Stile semplice e discorsivo, bisogna instaurare un rapporto quanto più possibile di confidenza con il lettore, chiedersi sempre “A chi mi rivolgo? Tutti possono capirmi?”. E poi, ogni tanto, stupire il lettore con delle immagini di noi stessi, magari per pubblicizzare un libro che ci è piaciuto, perché metterci la faccia paga sempre. Infine, saper utilizzare i social network nei tempi e nelle modalità giuste per la condivisione degli articoli.
Quando leggi un libro per farne poi l’oggetto della tua recensione, che sia sul blog Chez Giulia o su Il Messaggero, cosa vai a cercare in particolare? Su quali elementi soffermi la tua attenzione?
Cerco innanzitutto l’essenza: cosa vuole comunicare l’autore? Quali sono i temi chiave? E in base a questo mi chiedo: ne è stato capace? Sono riuscita a capirlo? Mi ha emozionato? Sembra banale, ma quando si recensisce un libro le impressioni “di pancia” sono sempre le prime di cui tener conto. Dopodiché arriva l’analisi dello stile, nel dettaglio, i confronti con altri libri che trattano la stessa tematica, magari anche il confronto con i classici, se il testo lo permette. Devo riuscire a trasmettere al lettore l’emozione che quel libro mi ha lasciato, solo così posso convincerlo a leggerlo.
Per fare una buona critica letteraria quali caratteristiche è indispensabile possedere?
Tanto studio, tanta preparazione, fare tesoro dei testi imprescindibili e degli insegnamenti universitari, come nel mio caso. Ovviamente poi bisognerebbe avere una grande curiosità – è la molla di tutto, va da sé che una persona curiosa sarà portata a mettersi in gioco e ad analizzare e confrontare più testi per appagare la sua sete di conoscenza – e lo spirito critico. Non tutti i libri sono belli, non tutti sono scritti bene, il che significa che bisogna, con obiettività, saper distinguere un buon elaborato da uno più scarso.
Quali sono i tuoi “ferri del mestiere”?
Chiaramente non posso prescindere dai testi universitari, dagli appunti – che ancora tengo sulla scrivania! – della professoressa Laura Melosi, docente di Storia della Letteratura italiana, del professor Roberto Cresti, docente di Storia dell’arte contemporanea, e poi i testi di critica letteraria di Pietro Citati (penso a “La malattia dell’infinito” o a “Il tè del cappellaio matto”), di Harold Bloom (fondamentale “Come si legge un libro e perché”), di Cesare Garboli e di Walter Pedullà. Per non parlare dei “Ritratti” di Arbasino e dei saggi di Debenedetti.
Quali responsabilità assume un critico letterario nei confronti degli autori, degli editori e, soprattutto, dei lettori?
Ha una grandissima responsabilità. Consigliare un libro è, in qualche modo, un atto di coraggio, perché un romanzo può salvarci la vita, così come può distruggercela. Il libro è un’arma molto potente, da non sottovalutare. Per quanto riguarda i giudizi, beh, credo siano più gli autori e gli editori a doversi assumere le adeguate responsabilità di ciò che viene pubblicato, nel senso che il critico letterario fa un’analisi di ciò che il mercato propone e poi ne dà un giudizio, positivo o negativo. Con garbo, con eleganza, motivando le scelte fatte e nel rispetto dell’autore, che non deve mai essere confuso, nel momento della recensione, con la “persona”.
Dei tuoi colleghi chi apprezzi di più, e chi invece non ti piace affatto?
Apprezzo moltissimo professionisti come Mario Baudino (La Stampa), Massimo Onofri (Avvenire) e Roberta Scorranese (Corriere della Sera, ma lei si occupa per lo più di arte), giornalisti che lavorano con passione ed entusiasmo, schietti e senza fronzoli. Apprezzo meno chi tenta di nascondersi dietro un dito, chi vuole a tutti i costi vendere per buona una merce che, in fondo, non lo è, e soprattutto non amo chi i libri non li legge fino in fondo e si affida solo alla quarta di copertina. Non è serio, soprattutto nei confronti del lettore.

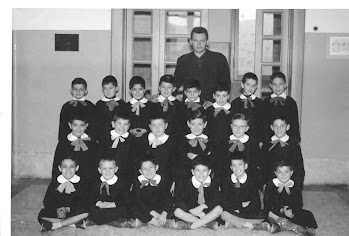


Commenti
Posta un commento