Olschki, una famiglia di “api” della cultura
Entrando in una normale libreria i suoi volumi non sono esposti in evidenza tra le novità del momento, né sono presenti in vetrina tra i libri dalle copertine vistosamente illustrate per poter attirare meglio l’occhio del passante. Eppure quando si ha la fortuna di poter tenere in mano un libro della casa editrice Leo S. Olschki di Firenze si ha subito l’impressione di avere a che fare con qualcosa di prezioso, che va anche al di là del suo contenuto, peraltro sempre di estrema qualità. La raffinatezza e la particolare cura di ogni edizione si notano già dalle eleganti e sobrie copertine con al centro il caratteristico logo che una volta Gabriele D’Annunzio definì “cuore crociato e diviso”. E poi la preziosità della carta e la perfezione della stampa che ancora oggi, nonostante l’uso delle moderne tecnologie, richiamano la sapiente arte della composizione tipografica che per oltre un secolo si è tramandata da proto a proto.
La casa editrice Olschki da sempre “s’identifica con il settore delle scienze umanistiche nella più vasta eccezione del termine” e ha da pochi mesi festeggiato il traguardo dei 130 anni di attività. La storia di questo emblema della cultura italiana ed internazionale è stata raccontata da Daniele Olschki, pronipote del fondatore, in una speciale lezione aperta al pubblico tenuta all’università di Macerata e rivolta agli studenti del corso di istituzioni di letteratura italiana tenuto dalla professoressa Laura Melosi.
Figlio di un tipografo prussiano, Leo Samuele Olschki, arriva in Italia nel 1883, all’età di 23 anni. Grazie alla sua conoscenza del greco e del latino e alla capacità di parlare diverse lingue, trova subito lavoro in una libreria antiquaria di Verona, ma già dopo tre anni decide di mettersi in proprio, espandendo i suoi interessi al settore editoriale. Fonda la rivista “L’Alighieri” e si trasferisce a Venezia dove rimane solo sette anni, prima di stabilirsi definitivamente a Firenze. Nel 1897 nella città toscana, assieme all’attività antiquaria, decolla quella editoriale con l’avvio di nuove collane di letteratura, linguistica e soprattutto di studi bibliografici. Tra le diverse collane, quella degli “Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia” farà la sua fortuna internazionale. Proprio grazie all’interesse per questi “cataloghi”, nel 1906 Leo Olschki riceve la visita inaspettata a Firenze del magnate americano John Pierpont Morgan, che oltre a curare i suoi interessi nella siderurgia e nella finanza ha una particolare passione per i libri antichi e rari. Morgan apre a Leo Olschki le porte del mercato americano dove ancora oggi, nonostante le edizioni della casa fiorentina siano in maggior parte in italiano, i libri con l’ormai celebre logo dell’editore toscano sono presenti in tutte le maggiori biblioteche degli Stati Uniti.
L’ulteriore sviluppo della casa editrice nei due decenni successivi subisce un freno verso la fine degli anni ’30 con il varo delle leggi razziali (nel 1939 viene revocata a Leo Olschki – che muore esule in Svizzera l’anno successivo – la cittadinanza italiana ottenuta nel 1926). Durante la seconda guerra mondiale i figli del fondatore, Cesare e Aldo, sono costretti a cambiare il nome della casa editrice che per alcuni anni si chiama Bibliopolis, salvando tuttavia il logo con lo stratagemma di attribuire le iniziali del fondatore al motto “Litterae servabitur orbis”.
Negli anni Cinquanta, scampato il tentativo di acquisto del ramo editoriale da parte di Enio Sindona, fratello del faccendiere Michele e già proprietario dell’Istituto Editoriale Italiano, la casa editrice riprende a svilupparsi e nel 1963 passa da Aldo, che muore il giorno della tragedia del Vajont (9 ottobre 1963), al figlio Alessandro.
Superate le difficoltà causate dall’alluvione di Firenze del 1966, che provoca la perdita dell’intero magazzino colmo di libri, la Casa editrice intraprende un nuovo fiorente cammino diventando il braccio editoriale delle più importanti istituzioni culturali italiane. Nascono così le collaborazioni con la Fondazione Cini, l’Accademia Colombaria, l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, la Società di Storia del Risorgimento ed anche del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, del quale pubblica e diffonde – tra l’altro – tutti i volumi che raccolgono gli atti dei vari convegni leopardiani.
Dal 1974 la casa editrice è in mano alla quarta generazione e con l’attuale amministratore delegato, Daniele Olschki, ha arricchito il catalogo in questi ultimi quarant’anni di oltre tremila titoli, molti dei quali hanno uno stretto legame con il territorio maceratese e con le istituzioni culturali della provincia. Della famosa collana “Inventari dei manoscritti delle biblioteche italiane”, avviata dal fondatore all’inizio del secolo scorso, nel 1981 il centesimo volume – curato da Aldo Adversi – è stato dedicato ai manoscritti della “Mozzi Borgetti” di Macerata e, nel 1993, il volume 107 della stessa collana è stato riservato alla biblioteca Valentiniana di Camerino. Negli anni Novanta, nella collana di studi bibliografici, la casa editrice fiorentina ha pubblicato un volume, “Una facoltà allo specchio”, a cura di Rosa Maria Borraccini e Luigi Verducci, dedicato alla facoltà di lettere dell’università di Macerata. Oltre agli atti dei convegni, sono una quarantina i titoli che negli ultimi decenni Olschki ha riservato alla figura e all’opera di Leopardi. Tra gli altri, “Giacomo, le donne e gli amori” e “Questa maledetta vita”, entrambi di Raffaele Urraro, “Leopardi, profili e studi” di Giuseppe Savoca, “La poesia pensa. Leopardi e la lezione del testo” di Piero Bigongiari, “Leopardi nel carteggio Vieusseux”, fino al recentissimo “Ius Leopardi” a cura di Laura Melosi, che contiene anche un saggio di Francesco Adornato.
Nel 2015 Olschki ha pubblicato due volumi dedicati a figure umanistiche del nostro territorio: “Nuove prospettive di ricerca sulla figura di Francesco Filelfo” e “Traiano Boccalini tra satira e politica”, entrambi frutto di due convegni di studi organizzati dall’Università di Macerata.
Si tratta di edizioni destinate soprattutto a studiosi, a volte veramente di “nicchia”, ma – come ha sottolineato il direttore del dipartimento di Lettere di Unimc, Carlo Pongetti – “capaci di fare la fortuna dei suoi autori”. Molto spesso le edizioni Olschki sono stampate con tirature limitate che restano a lungo nel “caveau” della casa editrice per una “distribuzione lenta nel tempo”, come la famosa edizione monumentale della “Divina commedia”, con prefazione di Gabriele D’Annunzio, stampata nel 1911 su carta filigranata fatta produrre appositamente a Fabriano e tirata in sole cinque copie, quattro delle quali vendute all’estero.
Oggi che il digitale sembra prendere il sopravvento, la casa editrice fiorentina – una delle poche tra quelle fondate in Italia sul finire dell’800 a rimanere “indipendenti” – si avvia ad affrontare questo inevitabile processo di digitalizzazione con la quinta generazione rappresentata da Serena Olschki. E lo fa con un preciso proposito: “non rinunciare mai al libro di carta” perché solo con esso il vero editore può svolgere appieno la sua funzione principale che – ha sottolineato Daniele Olschki – è quella di “impollinare” la cultura. Il rapporto che c’è tra un editore e il sapere è lo stesso che esiste tra le api e i fiori. (riproduzione riservata)
(Articolo scritto per Cronache Maceratesi.it, pubblicato il 2 marzo 2017)

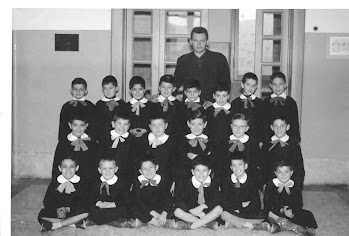


Commenti
Posta un commento