Marche. Un Pantheon di personalità che genera ancora stupore e appartenenza
© Tra gli anni ‘50 e ‘60, il marchigiano più nominato in pubblico, e quindi anche il più famoso in quel periodo, è stato Cesare Ionni di Macerata. Il suo nome, con l’aggiunta della città di provenienza, ogni domenica era pronunciato alla radio durante la trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto” e scandito dagli altoparlanti dei maggiori stadi d’Italia dove la famosa “giacchetta nera” maceratese era chiamata ad arbitrare le più importanti partite del massimo campionato di calcio.
Negli anni ‘70, un altro marchigiano e la sua città sono stati resi famosi dalla TV: Cesarini da Senigallia. Così, infatti, i titoli d’apertura delle popolari trasmissioni “Studio Uno” e “Canzonissima” indicavano lo scenografo del programma, il senigalliese Carlo Cesarini.
Se escludiamo grandi marchigiani di un lontano passato, come Raffaello, Gioacchino Rossini, Giacomo Leopardi (la cui marchigianità è nota anche per essere stati studiati a scuola), pochi sono i personaggi la cui terra d’origine è conosciuta fuori dai confini delle Marche. A quanti di noi, infatti, non è capitato, nel parlare con amici lombardi o siciliani, sentirsi rispondere, dopo aver citato “nomi” famosi della nostra regione: “..ma perché è marchigiano?”. È successo tante volte e sempre potendo notare meraviglia nel nostro interlocutore.
Ad eccezione dell’origine marchigiana di Enrico Mattei, cui tutta l’Italia deve molto, pochi sanno che erano marchigiani il padre dello Statuto dei Lavoratori, Giacomo Brodolini e il grande tenore Beniamino Gigli, così come lo scienziato Enrico Medi, l’economista Giorgio Fuà, il drammaturgo Ugo Betti, lo scrittore Libero Bigiaretti, lo scultore Giò Pomodoro, il “fotografo delle dive” Arturo Ghergo, il regista di tanti film di Totò, Mario Mattoli, le attrici Ave Nichi e Valeria Moriconi, i cantanti lirici Franco Corelli e Renata Tebaldi e due dei cantanti di musica leggera più in voga negli anni ’60, Tony del Monaco e Jimmy Fontana.
Pochi milanesi sono a conoscenza che Ercole Rosa, autore del monumento a Vittorio Emanule II al centro di piazza Duomo, era d’origine marchigiana. Nello stesso mondo del giornalismo non tutti sanno che era salito a Milano dalle Marche il più noto dei direttori del Corriere della Sera, Luigi Albertini, alla guida del giornale dal 1900 al 1925.
Era marchigiano anche il Segretario di Stato vaticano Pietro Gasparri, che nel 1929 firmò con Mussolini i Patti Lateranensi e dalle Marche provenivano ben dieci Papi, tra cui i più famosi Sisto V (Felice Peretti) e Pio IX (Giovanni Mastai Ferretti).
Questi, ma non solo loro (l’elenco sarebbe lungo), hanno reso lustro alla regione. La Giornata delle Marche, che quest’anno ricorda Carlo Urbani, medico rimasto vittima della SARS, la malattia da lui stesso per primo identificata, dovrebbe essere idealmente dedicata a tutti coloro che sono stati “testimonianze della comunità marchigiana, contribuendo a rafforzarne la conoscenza e il senso di appartenenza”. Tra questi non vanno dimenticati le migliaia di marchigiani che all’inizio del secolo scorso emigrarono in Argentina o in altre parti del mondo e che da lontano hanno amato le Marche forse più di ogni altro.
(questo articolo è stato scritto per Emmaus in occasione della Giornata delle Marche 2013 ed è stato pubblicato sul n. 45 del 7 dicembre 2013)

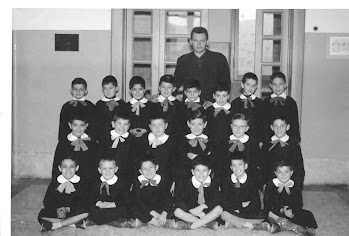


Commenti
Posta un commento