La tazzina da caffè, stravagante non è utile.
Illustrazione di Giulia Rossi per Espresso Ideas
(Questo articolo è stato scritto per Espresso Ideas by Simonelli Group, pubblicato sul n. 17-18, novembre 2016)
Caffetteria che vai, tazzina che trovi. Che si ordini un espresso al bancone, o che si chieda di servircelo al tavolo, prima ancora di gustare il caffè siamo tutti portati a osservare la tazzina che lo contiene. A volte la troviamo secondo i nostri gusti o come riteniamo che debba essere. Altre volte, la tazzina ci incuriosisce per la sua forgia, per lo stile o il colore o per qualche sua strana caratteristica e se ci capita di non trovare eccellente l’espresso bevuto, magari ne attribuiamo parte delle colpe proprio alla tazzina.
Tazzine di porcellana spessa o più sottile, tazzine alte e strette o larghe e basse, con il manico piccolo o ben evidente, tutte bianche o con la parte esterna colorata oppure disegnata, il tutto sempre coordinato con il relativo piattino. A volte troviamo addirittura tazzine che nella forma richiamano altri oggetti di uso comune che nulla hanno a che fare con il caffè. Per chi ama bere l’espresso anche in casa la scelta di tazzine in commercio è praticamente infinita e nei negozi specializzati se ne trovano di ogni forma e tendenza, dalle più classiche alle più bizzarre.
Un oggetto di così largo uso come la tazzina da caffè non poteva sfuggire all’interesse dei designer. Migliaia di tazzine sono opera di professionisti del disegno industriale. Alcuni di loro, molto famosi, hanno disegnato tazzine per importanti industrie del settore.
Si sono cimentati nel progettare tazzine anche noti architetti internazionali, come ad esempio il britannico David Chipperfield il quale ha disegnato per la serie “Hupla”, una tazzina quasi cilindrica cui è abbinato un piattino che permette di adagiarvi completamente il cucchiaino. Il suo connazionale Will Alsop, invece, per la stessa industria di accessori di design per la cucina, ha disegnato la tazzina “Hazel” la cui base inferiore nasconde un bicchierino per il latte o per un liquore da bere dopo il caffè. L’artista cinese Xie Dong ha progettato “Adelaide XIV”, una tazzina con piattino, dove viene reinterpretata la lavorazione della ceramica tradizionale cinese unita alla realizzazione degli origami. Per ogni singolo pezzo, fabbricato a mano e firmato dall’artista, la porcellana è lavorata per ottenere uno spessore estremamente fine, somigliante ad un foglio di carta sgualcito. Il designer italiano Matteo Thun, della cui più nota tazzina parleremo più avanti, ha invece ridisegnato la tazza tradizionale in porcellana classica bianca sostituendo il manico con un anello in plastica isolante che consente di afferrarla con le mani senza rischiare di bruciarsi.
Tra le più stravaganti c’è la Cookie Cup, la tazzina ideata dal designer venezuelano Enrique Luis Sardi per il torrefattore Lavazza. È una tazzina che si può mangiare; una speciale glassa alla vaniglia (oppure, a scelta, al cioccolato), rende la tazza-biscotto di pasta frolla impermeabile. Curiosa anche la tazzina ideata dalla designer francese Geraldine De Beco, dove una volta versato il caffè appaiono – in virtù dell’interno non completamente liscio – figure di animali.
Tazzina o opera d’arte?
Cos’è e a cosa deve servire una tazzina da caffè? La risposta a questa semplice domanda è altrettanto naturale: un piccolo oggetto d’uso quotidiano in grado di racchiudere e consentire di far assaporare il gusto unico di un buon espresso.
C’è allora da chiedersi se una tazzina possa essere un’opera d’arte. Trattandosi di oggetti da produrre in serie, cioè industrialmente, la risposta non può prescindere dal concetto di disegno industriale, cioè di design.
Un oggetto di design è un’opera dell’ingegno, ma deve rispondere innanzitutto a criteri di funzionalità, all’uso pratico cui l’oggetto è destinato. Nell’oggetto di design l’essere “opera d’arte” sta nello stile con cui debbono essere, previsti, disegnati e amalgamati tutti gli elementi ottimali e indispensabili all’essere funzionale e, possibilmente, a migliorarne l’utilizzo. Uno che di stile se ne intende, come Giorgio Armani, dice che esso “è una questione di eleganza, non solo di estetica; è trovare la novità e l’invenzione senza dover far ricorso alla stravaganza”.
Deyan Sudjic, direttore del Design Museum di Londra, nel suo saggio “The Language of Things” ha scritto che “il design è il linguaggio che una società usa per creare oggetti che riflettono i suoi scopi e i suoi valori”.
La tazzina ideale
Tornando all’oggetto del nostro discorso, una tazzina vale l’altra? Oppure è possibile configurare la tazzina pura, ottenendo il massimo surplus estetico, una forma in grado di mantenere in modo ottimale il calore del caffè e di esaltarne al meglio l’aroma, ottimizzando la prestazione d’uso?
Se affermiamo che la progettazione di una tazzina da caffè debba rispondere agli scopi e ai valori per i quali essa viene utilizzata da chiunque desideri offrire o bere un ottimo espresso, occorre domandarci: esiste una forma perfetta per la tazzina?
Serena Treppiedi, una studiosa di disegno industriale con un grande amore per il caffè, convinta che sia estremamente importante avere la tazzina giusta per gustarlo al meglio, ha affrontato il problema iniziando da un tema classico e cruciale del design. È andata alla ricerca dell’archetipo estetico e funzionale, cioè di quel modello originario dell’oggetto di uso comune che porta a definire la cosiddetta “forma perfetta”. Del resto “il disegno industriale – come ha scritto Dario Russo, art director della Società Italiana d’Estetica – è esso stesso archetipo nella misura di astrazione mentale, schema, ovvero disegno tecnico, utile a produrre in serie una certa quantità di prodotti”. Più che l’oggetto concreto, l’archetipo è il comun denominatore del progetto; il punto da cui partire che, per gli oggetti d’uso comune, tra origine nell’uso “primitivo” dell’oggetto stesso e dalla semplicità ripetuta nel tempo.
Per fare ciò la designer è partita dalle caratteristiche “certificate” dall’Istituto internazionale degli Assaggiatori di caffè, secondo cui la tazzina in grado di garantire ed esaltare le caratteristiche dell’espresso “doc” deve essere dotata di fondo interno ellittico senza spigoli (per assicurare un’ottima crema), di spessori variabili che si assottigliano verso il labbro, di un ampio spazio di testa (per lasciare un volume maggiore agli aromi) e deve essere realizzata in porcellana di color bianco brillante. In base a tali elementi la studiosa si è chiesta che aspetto debba avere una tazzina “ideale” che, con tutte le predette caratteristiche, apporti massima qualità all’esperienza del caffè, e che sia dunque anch’essa perfetta.
In un’intervista rilasciata a “Il caffè delle cinque”, Serena Treppiedi ha raccontato il metodo seguito: “Attraverso un meccanismo di astrazione e purificazione da ogni stilismo superfluo e utilizzando lo stesso metodo di ‘interpolazione’, applicato dal famoso grafico svizzero Adrian Frutiger per lo studio dello scheletro comune ai caratteri tipografici, ho ricercato un minimo comune multiplo tra tutti i profili di tazzine più diffusi e li ho sovrapposti rintracciandone la forma comune. A questo profilo ho poi applicato in ogni dettaglio le caratteristiche necessarie a mettere in forma una tazzina esteticamente ideale e funzionalmente perfetta”.
Pubblicato con il titolo “L’espressione dell’espresso. Archetipo della tazzina per il rito del caffè”, lo studio di Serena Treppiedi parte dal Settecento, quando in Europa incominciarono ad essere importati sia il caffè che la porcellana. All’epoca non esisteva un oggetto pensato per bere caffè. La prima vera tazzina arrivò intorno al 1900 e prese il nome dal suo ideatore, Luigi Tazzini, direttore artistico della Richard Ginori, che la progettò ispirandosi alle tazzine orientali.
Delle tante tazzine esaminate, la ricercatrice ha preso in esame due parti: il corpo e il manico. Andando avanti con l’interpolazione ha selezionato le forme più comuni trovando il punto di sovrapposizione. Ha poi preso in considerazione i parametri ritenuti essenziali dagli assaggiatori di caffè in termini di volume (25 millilitri, ovvero 25 mm3 cui va aggiunto lo spazio di testa) ha sviluppato con un programma CAD il volume equivalente in forma ellittica, proporzionando poi il profilo esterno. Ha quindi tenuto conto degli spessori tra il volume interno e il profilo esterno (due millimetri per il bordo superiore, cinque millimetri all’altezza della “pancia” della tazzina, due millimetri anche per il fondo). Dopo varie prove su diverse forme interne, ha tracciato la curva media tra quelle analizzate e una volta definita l’ha applicata al profilo esterno, tenendo conto degli spessori. Ha trovato così la forma e le dimensioni della tazzina-archetipo. Per quanto riguarda il manico ha selezionato i più comuni, li ha sovrapposti per trovare il profilo medio e la posizione più ricorrente della tazza su cui unirli, omogenizzando gli spessori con un’ampiezza di sette millimetri.
Con lo stesso procedimento ha poi disegnato anche il piattino e ricercato il cucchiaino più coerente, individuandolo in quello progettato da Davide Oldani, che, essendo forato, mescola senza disgregare, preservando quindi tutte le caratteristiche organolettiche dell’espresso.
La tazzina di design
Tornando allora ad una delle domande iniziali, una tazzina da caffè può essere un’opera d’arte?
Non è questa la sede per entrare nel dibattito su ciò che sia arte e ciò che non lo sia. Limitiamoci a richiamare l’orientamento prevalente riguardo la differenza tra l’arte e il design e in particolare su quale sia il confine tra queste due discipline. Entrambi hanno una ricercatezza dal punto di vista estetico, ma la particolarità che più le differenzia è l’assenza di funzionalità in un’opera artistica, funzionalità che, invece, diventa fondamentale in un oggetto di design, creato e disegnato per soddisfare una qualsiasi necessità, migliorando la qualità della vita.
Ogni oggetto di uso comune – e la tazzina da caffè senza alcun dubbio lo è – può essere “di design” quando tutti i suoi elementi, pur progettati con aspetti di innovazione estetica, non tradiscono l’essenzialità per l’uso corretto a cui l’oggetto stesso è destinato.
Una tazzina da caffè che si avvicina, fino a quasi identificarsi con esso, all’archetipo individuato dallo studio di Serena Treppiedi è la tazzina da bar voluta nel 1990 da Francesco Illy, progettata dal designer Matteo Thun. Questa tazzina, in porcellana bianca, è in seguito diventata la base sulla quale il famoso torrefattore triestino ha creato la serie di “tazzine d’autore Illy collection”. Tazzine che sono diventate da collezione poiché esternamente decorate da artisti già affermati e da talenti emergenti dell’arte contemporanea. È questo un caso in cui un oggetto d’uso comune diventa un’opera di design e nello stesso tempo un’opera d’arte. Qui, infatti, la creatività dell’artista non modifica, né nasconde, l’innovazione estetica apportata dal designer e l’opera progettata da quest’ultimo non trascura, anzi ottimizza, tutti quegli elementi essenziali a consentire il corretto uso per cui l’oggetto è prodotto.
(Questo articolo è stato scritto per Espresso Ideas by Simonelli Group, pubblicato sul n. 17-18, novembre 2016)

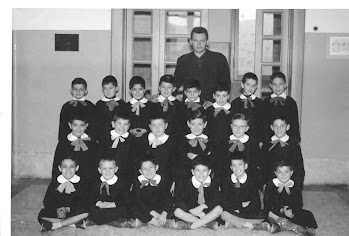


Commenti
Posta un commento