Il “design è l’albero, non la mela”.
Illustrazione di Giulia Rossi per Espresso Ideas
Dal mattino, quando prendiamo in mano il rasoio per raderci o ci sediamo a tavola per fare colazione, così come guidando l’automobile o dovendo fare il biglietto del treno alla cassa automatica e durante tutta la nostra giornata lavorativa, fino ai momenti di relax serali mentre, seduti in poltrona, utilizziamo il telecomando del televisore o di un apparecchio per ascoltare la musica, abbiamo a che fare con il design. Non sempre ce ne rendiamo conto, ma l’impugnatura del rasoio e delle posate, come lo schienale dell’auto e la poltrona di casa le troveremo tanto più comode da usare e confortevoli quanto più saranno stati progettati tenendo conto delle esigenze psicofisiche di chi li usa. Così sarà anche per gli attrezzi da lavoro, come per le schermate della biglietteria automatica o i tasti del telecomando che dovranno risultare così intuitivi da poter essere utilizzati da tutti con estrema facilità.
Il design si è evoluto nel tempo con la trasformazione della produzione industriale e spesso ha addirittura aperto una finestra sul futuro dei sistemi produttivi. Esso è anche cambiato con i progressi della tecnologia, ma ha accompagnato anche i mutamenti sociali e dei costumi. Il design è all’origine di tutto quanto oggi entra nella nostra vita, sia come oggetti, sia in cose immateriali. La stessa definizione di design si è necessariamente sviluppata tanto da comprendere quel processo globale di progettazione nel quale convergono ideazione, produzione, comunicazione, utilizzo, consumo e perfino riuso di oggetti e materiali.
Nel precedente numero di Espresso Ideas– nell’articolo dedicato alla progettazione della tazzina da caffè – si è fatto cenno al rapporto tra design e arte, sottolineando come il design non possa identificarsi con l’arte in senso lato in quanto esso deve seguire processi e regole precise che gli consentano di essere anello di congiunzione e nello stesso tempo sintesi tra ingegneria, architettura, innovazione, stile, produzione e mercato. Per questo il designer nel suo lavoro deve avere uno sguardo attento a tutto il mondo che ruota attorno all’idea: dal progetto all’evoluzione, dalla produzione alla distribuzione, interfacciandosi non solo con l’industria che andrà a produrre quel determinato bene, ma anche con l’economista, con l’esperto di marketing e tenendo conto di principi della psicologia.
Non a caso uno degli autori oggi più seguiti e letti tra gli stessi designer è Donald Norman, considerato – benché laureato in ingegneria elettronica presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) – uno dei padri della moderna psicologia cognitivista. Già professore di psicologia e scienze cognitive e direttore dell’Istituto per la Scienza Cognitiva dell'Università della California (San Diego), attualmente insegna alla Northwestern University di Chicago e il suo campo di ricerca è lo studio dell'ergonomia, del design, e più in generale del processo cognitivo umano. Nei suoi due libri più noti, “The design of everyday things” ed “Emotional design”, Norman affronta due temi distinti, ma che necessariamente debbono coesistere: ergonomia ed emotività. “Quando ci arrendiamo di fronte a oggetti che non siamo in grado di maneggiare – scrive Norman nel primo libro – non significa che siamo incapaci di usarli; la vera questione è che siamo alle prese con oggetti mal progettati”. Nello stesso tempo “non si può non tenere conto – ci dice l’autore nel secondo volume – del piacere che ci procurano o meno gli oggetti che usiamo quotidianamente: li scegliamo, li apprezziamo non solo per la funzione che svolgono per noi, ma anche per le sensazioni che ci danno”.
La gratificazione emotiva del design
Un precursore delle tesi di Norman è stato un non designer, che forse oggi dovremmo definire un “designer ad honorem”, ovvero Steve Jobs. Il genio della Apple, che non aveva conoscenze scientifiche su questo campo, ma aveva sicuramente un grande senso estetico improntato al “buon gusto”, ha fatto di questa sua dote la fortuna dell’azienda che oggi tutti conosciamo e dei prodotti che apprezziamo per il loro design, prima ancora che per la loro pur elevata tecnologia.
Se c’è un prodotto che grazie al suo design ha determinato il successo dell’intera azienda produttrice, questo è il primo iMac, il computer colorato a forma di goccia. Nel 1997, quando Steve Jobs rientra alla Apple dopo dodici anni da quando si era dimesso per contrasti con il management, l’azienda era in declino. Il nuovo Mac, voluto da Steve Jobs e realizzato secondo le sue indicazioni, conquista subito sia la fiducia degli utenti, sia del mercato.
Una delle frasi che Steve Jobs amava ripetere ai suoi collaboratori era “La gente non sa ciò che vuole, finché non glielo fai capire tu”. Questo significava che il prodotto deve andare oltre le aspettative degli utenti, i quali nel vedere la novità debbono restare sorpresi e la sorpresa dovrà dare loro quell’emozione da cui non si distaccheranno più. Un altro concetto che stava a cuore a Steve Jobs era che “il design non riguarda solo l’aspetto esteriore del prodotto, ma ne deve riflettere l’essenza stessa”. Per questo la filosofia alla Apple dopo il rientro di Jobs non fu più che i designer dovessero “impacchettare” quello che gli ingegneri avevano progettato, ma che l’intero prodotto dovesse nascere dalla costante e parallela collaborazione tra designer, sviluppatori del prodotto, ingegneri. Semmai, da qual momento in poi, sarebbero stati proprio i designer a dettare la linea della progettazione ingegneristica. Illuminanti sono in tal senso alcune pagine della biografia di Steve Jobs scritta dopo la sua morte da Walter Isaacson, specie dove si narra della realizzazione nel 1997 dell’iMac, il primo computer da tavolo destinato al mercato home consumer, nato dalla collaborazione tra Jobs e il designer Jonathan Ive.
L’iMac è il risultato di un altro concetto basilare della filosofia di Steve Jobs riguardo al prodotto: “La semplicità è la maggior sofisticazione”. Jobs - che fin da giovane era stato un ammiratore della scuola di architettura, arte e design sviluppatasi negli anni Venti del ‘900 in Germania con il nome di Bauhaus, caratterizzata dallo stile semplice, pratico e funzionale - fin dai primi anni Ottanta, in occasione dell’originario Macintosh, aveva spinto i designer di allora ad ispirarsi ai prodotti della Braun degli anni Sessanta del designer tedesco Dieter Rams, autore anche di un “decalogo” del buon design. Prodotti quindi “semplici”, con uno stile minimalista, ma tutt’altro che “freddi”.
Jobs ricordava che la gente, almeno all’epoca, non si sentiva a suo agio con la tecnologia e che di conseguenza per avvicinarla ai prodotti tecnologici occorreva che questi fossero invitanti, anche in senso fisico. La scocca dell’iMac fu progettata per avere una forma “divertente”. Essa doveva trasmettere anche il senso di semplicità, “rivelando nel contempo tutta la profondità che la vera semplicità racchiude in sé”. Doveva essere semitrasparente per far familiarizzare visivamente l’utente con le parti elettroniche e per il colore fu scelto un verde-azzurro chiamato “azzurro bondi”, dal nome di una spiaggia australiana dove la trasparenza dell’acqua del mare aveva quel colore. Suggello dell’opera di design fu la maniglia nella parte posteriore della macchina. Era un elemento più giocoso che di vera utilità in quanto l’iMac non era un computer da portare in giro, ma secondo Ive e Jobs, serviva a rendere “avvicinabile” l’oggetto rendendolo “amichevole e giocoso”. L’iMac fu messo in vendita il 15 agosto 1998 ed il successo fu immediato. Costava 1299 dollari e ne furono venduti 278mila esemplari nelle prime sei settimane e ben 800 mila entro i tre mesi successivi. Un aspetto importante per la Apple fu che ben il 32% degli acquirenti non aveva mai acquistato prima un computer e un altro12% era stato cliente della principale azienda concorrente.
L’iMac è rimasta un’icona del design e da allora lo stile Apple continua ad essere un elemento vincente delle strategie aziendali che ha fatto del design (non solo del prodotto esteriore, ma anche dei simboli grafici del sistema operativo e perfino del packaging) un elemento “emozionale” e identitario per eccellenza.
La Apple è forse l’azienda che più di altre e prima di altre ha messo in pratica le teorie di Donald Norman (che per altro è stato alcuni anni vicepresidente del gruppo di ricerca sulle tecnologie avanzate per l’azienda di Cupertino) secondo cui il design del prodotto e anche del packaging deve rispondere ad una serie di esigenze poste dal consumatore, semplicità d’uso unita all’aspetto ergonomico e gratificazione sensoriale ed emotiva derivanti dall’acquisto e dall’utilizzo.
Semplicità è bellezza
Eppure la maggior parte della gente ha oggi un concetto sbagliato di design. Privato spesso della sua connotazione progettuale, oggi esso mette insieme tre banali caratteristiche: moderno, tecnologico e soprattutto “bello”. Il designer è visto come una via di mezzo tra l’artista e l’inventore, che trasforma prodotti mediocri in prodotti belli. Ed è forse proprio il comune concetto di bellezza quello che nelle persone contribuisce di più a distorcere il vero significato di funzione del design.
“Il bello nel design è scontato”, dice il designer Riccardo Diotallevi, docente alla Scuola di architettura e design dell’Università di Camerino (Italy) e componente del consiglio esecutivo dell’Associazione per il disegno industriale. “Design è piuttosto qualcosa che va incontro alle necessità delle persone, che si “autospiega” poiché come una macchina si accende e come si usa deve essere insito nell’oggetto e le istruzioni scritte sono qualcosa per di più da mettere nella confezione. Ma è anche genialità dell’invenzione, diventando esso stesso brevetto di innovazione, come ad esempio la cerniera lampo (zip) o la chiavetta per aprire le scatole del lucido per le scarpe”.
Il motore dell’economia è trasformare le idee in innovazione. Questo vale per la tecnologia, ma anche per il design, “specie quando questo – come ha scritto una volta Mario Moretti Polegato, patron della Geox – rende semplici le cose belle”.
Dieter Rams, il designer tedesco che ha realizzato i prodotti di maggiori successo della Braun (molti esposti al Moma di New York), tra cui il famoso “giradischi sk-4”, e al quale lo stesso Steve Jobs faceva riferimento quando dava indicazioni ai suoi progettisti-designer, anni fa ha indicato i dieci principi per un buon design di prodotto: deve essere innovativo, rendere il prodotto utile, essere dotato di estetica, aiutare a capire il prodotto, non deve essere invasivo o mancare di riservatezza, deve essere onesto, essere durevole, essere la conseguenza dell’ultimo dettaglio, si deve preoccupare dell’ambiente e deve contenere il minor design possibile.
La Braun prima e la Apple dopo hanno calato questo decalogo non solo nei loro prodotti, ma ne hanno fatto identità del loro brand. La coerenza dei contenuti dei prodotti di un’azienda è un elemento sempre più distintivo e identitario. Proprio per questo – spiega Riccardo Diotallevi – tutte le maggiori aziende, pur facendo ricorso a diversi designer, hanno una direzione artistica che individua i professionisti per ogni singolo prodotto sulla base di una comunicazione coerente con l’immagine del brand”.
Un’azienda di prodotto che voglia essere davvero competitiva non può fare a meno di impostare una strategia che veda il “fattore design” come una leva a disposizione dello sviluppo da inserire all’interno di una dinamica più ampia. La Kartell, azienda che produce componenti di arredo in materiale economico come la plastica, è un tipico esempio di coerenza di contenuti in cui la grande attenzione per il design non è disgiunta dalla forte spinta alla continua innovazione.
In questi contesti, gli aspetti costruttivi, non possono ignorare quelli comunicativi, così come le strategie di distribuzione e vendita del prodotto. L’azienda “design-oriented” deve avere una progettualità complessiva perché – come afferma Riccardo Diotallevi usando una efficace metafora, “il design è l’albero e non la mela”.
Design “evergreen”
Oggi tutte le aziende che competono sui mercati internazionali ricorrono alla creatività e all’intelligenza di famosi designer, ma non dobbiamo dimenticare che la storia industriale e il nostro costume, quindi la nostra società, devono molto a quel design cosiddetto “anonimo” con il quale abbiamo a che fare in ogni momento della giornata. Design “anonimo” non perché senza autore – ogni oggetto, del resto, è frutto di un pensiero progettuale – ma anonimo perché non conosciamo il nome del designer (e a volte nemmeno dell’azienda produttrice). L’autore non ci è noto perché a suo tempo risultava irrilevante farlo conoscere o perché negli anni se ne è persa la documentazione. In alcuni casi si tratta di design di tradizione, radicato in una civiltà preindustriale che ci ha tramandato oggetti ancora oggi in uso e prodotti, come ad esempio il fiasco per vino (di vetro e impagliato) oppure il litro di vetro (nato secoli addietro per identificare l’unità di misura) o il metro di legno estensibile e la sedia pieghevole da osteria, che risalgono entrambi alla seconda metà dell’800.
A parte questi casi, particolarmente datati, ci sono “anonimi” che – benché brevettati e protetti – sono nati dall’ingegno di quanti lavoravano negli uffici tecnici di aziende sviluppatesi nel corso del Novecento attraverso la lenta ma inarrestabile trasformazione di tante botteghe artigiane. È questo il caso, ad esempio, della “Poltrona 904” realizzata nel 1930 da Poltrona Frau, archetipo della più nota Vanity prodotta, con limitate variazioni, a partire dal 1982. Altro esempio, gli occhiali da sole modello 649 della Persol del 1938 così come la cucitrice Zenith 548 del 1948. E, ancora, il doposci Moon Boot lanciato nel 1970 da Tecnica e il guscio di gomma per telecomando della Meliconi del 1987.
Si tratta di oggetti che dal punto di vista del design risultano tutt’altro che banali. Sono prodotti da moltissimi anni e chi non ne conosce le origini potrebbe essere indotto a pensare che sono contemporanei, stante il fatto che si trovano facilmente in commercio e sono usati quotidianamente. Ciò che conta – come ha sottolineato Alberto Bassi, docente di storia del design allo IUAV di Venezia, che ha censito oltre settanta oggetti di design anonimo – “è che tutti contengono un’idea, costituiscono la soluzione più o meno semplice di un problema, esibiscono caratteri di piacevolezza formale. E il fatto che sappiamo poco o nulla di loro non importa: sono necessari, alcuni indispensabili, funzionano e questo basta”. Rispondono in pratica ad un concetto basilare del design: sono stati realizzati per venire incontro alle necessità delle persone e continuano ad assolvere questa loro funzione. Se poi oggi non ci emozionano, non vuol dire che un tempo non abbiano provocato anche quest’altro effetto. (riproduzione riservata)
(Articolo scritto per Espresso Ideas by Simonelli Group n. 19-20, novembre 2017)

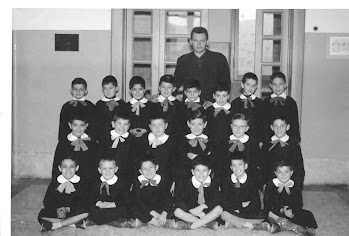


Commenti
Posta un commento