È tutta una questione di sensi
© I migliori chef amano spesso ripetere che “si mangia prima con gli occhi e per ultimo con la bocca”. Quando siamo davanti ad una tazza di caffè, peraltro, prima che con il palato l’espresso lo “assaggiamo” con gli occhi ed anche con il naso.
Capita spesso, mentre siamo al ristorante, di vedere qualcuno seduto al tavolo vicino al nostro che d’istinto, ancor prima di assaggiare il cibo che gli è stato servito dal cameriere, fa una bella foto al piatto con lo smartphone per condividerla poi con i propri amici sui principali social network e far venire loro l’acquolina in bocca. È l’evoluzione “2.0” del detto “mangiare con gli occhi”. Il piacere del cibo, infatti, è prima di tutto anche visivo. Lo sanno bene gli chef che preparano i piatti come se fossero sculture o dipinti dai colori vivaci.
È fondamentale, quindi, che per essere totalmente apprezzato il cibo sia anche il più possibile attraente e seducente. Se vediamo un piatto di pasta traboccante di sugo, una torta farcita o una bella coppa di fragole con la panna… il risultato è sempre quello: la vista stimola il nostro desiderio di mangiare a tutti i costi quella pietanza.
Studi scientifici hanno cercato di dimostrare che quando siamo affamati udiamo le parole inerenti al cibo in modo più chiaro e nitido rispetto agli altri vocaboli.
Quando si mangia, odore e sapore si percepiscono insieme e questo ci permette di distinguere gli alimenti. Se annulliamo l’olfatto, il gusto da solo ci può trarre in inganno.
A volte prima di assaggiare un cibo solido – pensiamo ad esempio a un frutto – siamo portati a giudicarne con il tatto lo stato di maturazione, nonché la consistenza e in parte la qualità. Ma utilizziamo il tatto anche con i liquidi, come vino e caffè, mettendo in funzione specifici sensori presenti nella bocca e che reagiscono a stimoli indotti da viscosità, temperatura, astringenza, gas disciolti, causticità.
Ecco quindi come nel bere e nel mangiare tutti i cinque sensi risultano impegnati.
La percezione sensoriale svolge un ruolo fondamentale nella nostra vita. Nella quotidianità usiamo istintivamente i sensi nel compiere le nostre azioni, sia che acquistiamo un'automobile, sia che ascoltiamo una canzone o mangiamo – appunto – un determinato cibo.
“Sin dalla nascita, nelle scelte e nella comprensione del mondo che ci circonda, siamo guidati dai nostri sensi”, ci ricorda Lucia Irene Bailetti, ingegnere alimentare di nazionalità argentina, attualmente direttrice del Centro italiano di analisi sensoriale e dal 2005 membro dell’Institute of Food Technologist di Chicago (USA). “Spesso e inconsapevolmente – ci dice – siamo portati a dare poca importanza alla modalità in cui li utilizziamo, ma i nostri sensi, insieme al nostro sistema cognitivo, fanno da padrone nelle nostre scelte di consumo quotidiane. A volte ci sembra banale, ma è necessario concedersi un po’ di tempo per ‘riascoltare’ gli odori, i colori e i suoni dei paesaggi, o ritrovare i sapori, gli aromi dell’infanzia o per fermarsi a conoscerne dei nuovi. Attraverso l’esperienza della vista, del tatto, del gusto e dell’olfatto acquisiamo coscienza su ciò che accade intorno a noi e sviluppiamo quindi la consapevolezza anche su ciò che mangiamo e beviamo tutti i giorni”.
Se consideriamo le nostre scelte alimentari, infatti, ci accorgiamo che alla base di esse vi sono moltissimi fattori che in vario modo le influenzano. Si tratta di aspetti sensoriali, ma anche biologici e socio-culturali.
L’impressione che abbiamo di un cibo, nel momento in cui lo assaggiamo, è determinata da un insieme di stimoli che coinvolgono i diversi sensi. Ne percepiamo il colore, la forma e l'aspetto, ma siamo influenzati anche dall'odore e dal sapore che li caratterizzano. Olfatto e gusto sono i cosiddetti “sensi chimici” le cui percezioni sono legate direttamente alla composizione degli alimenti. Spesso si tende a sottovalutare l'olfatto, ma molte delle sensazioni che vengono dal cibo sono legate alla stimolazione olfattiva. Il naso può riconoscere centinaia di sostanze diverse e con maggiore sensibilità, al contrario del gusto che deriva dalla combinazione di cinque pilastri fondamentali: dolce, salato, amaro, acido e umami. Quest’ultimo è il cosiddetto “quinto gusto” sensibilizzato dal glutammato e da diversi ribonucleotidi, tra cui inosinato e guanilato, che si trovano naturalmente in carne, pesce, verdura e prodotti lattiero-caseari.
Ingegner Bailetti, che grado di consapevolezza abbiamo di tutto questo noi consumatori?
La consapevolezza oggi, gioca un ruolo centrale: i consumatori sono molto più esigenti, c’è una domanda crescente di prodotti e servizi ‘customizzati’ che in qualche modo arricchiscono l’esperienza di consumo; ciò accade non solo nel settore del food. Pensando ad esempio alla domotica o al settore automobilistico, o all’interfaccia degli smartphone e dei tablet, si possono fare infiniti esempi nei quali la tecnologia va di pari passo con lo studio della user and sensory experience.
In questo scenario sentiamo spesso parlare di ‘sensorialità’ o, nello specifico, dell’utilizzo dell’analisi sensoriale. Cos’è in realtà l’analisi sensoriale?
È una disciplina scientifica utilizzata per evocare, misurare, analizzare e interpretare le caratteristiche di un prodotto attraverso i sensi.
Per distinguere i singoli stimoli o per descrivere esattamente le caratteristiche sensoriali di un prodotto è necessario essere allenati. La ricerca scientifica ha definito degli standard internazionali per l’addestramento degli assaggiatori professionali, per la definizione del linguaggio che deve essere uniforme e internazionalmente riconosciuto e per la definizione delle modalità con le quali devono essere scelti e svolti i test in relazione alla problematica da analizzare.
Nello specifico a cosa serve l’analisi sensoriale?
L’analisi sensoriale definisce il profilo sensoriale dei prodotti, sia dal punto di vista qualitativo, attraverso l’individuazione delle caratteristiche distintive del prodotto percepite dall’assaggiatore professionale, sia dal punto di vista quantitativo, attraverso il grado d’intensità dello stimolo individuato dall’assaggiatore. Questa disciplina permette quindi di delineare un profilo sensoriale per descrivere in modo univoco e oggettivo un prodotto. Le applicazioni dell’analisi sensoriale sono molteplici: il controllo delle materie prime, lo sviluppo di nuovi prodotti, il confronto sensoriale durante la shelf life, il confronto con prodotti omologhi nel mercato, e molte altre ancora.
Si tratta quindi di mettere in correlazione le caratteristiche intrinseche del prodotto con le percezioni sensoriali?
Non solo. Parlare di analisi sensoriale solo in termini di correlazione tra caratteristiche intrinseche del prodotto e percezioni sensoriali è riduttivo. Oggi, infatti, la scienza sensoriale si occupa, insieme alla scienza di consumo, di individuare gli aspetti del prodotto che possono emozionare e conquistare il consumatore. È ormai noto, d’altra parte, che le logiche che ci guidano al momento della scelta di consumo non ricadono su motivazioni esclusivamente legate all’aspetto economico, ma tengono conto della combinazione di diversi fattori, quali – ad esempio – quello geografico, socio-culturale, sensoriale e psicologico.
Se originariamente il sistema percettivo era legato in maggior misura all’istinto, oggi esso coinvolge molti più fattori, conseguenza questa, della crescita di complessità del cervello umano, e delle dinamiche che muovono il mondo intero. Per questo è importante capire gli stimoli che originano e influenzano l’esperienza di consumo e la percezione di piacere collegata ad essa.
Un’altra espressione di cui si sente molto parlare è ‘sensory branding’. Di cosa si tratta?
Oggi un numero sempre crescente di aziende utilizza stimoli olfattivi, uditivi e tattili per stabilire una forte connessione emotiva con i propri clienti e per far sì che le preferenze di questi ultimi si rivolgano al loro brand. Questo è il ‘sensory branding’, uno strumento importantissimo mediante il quale le aziende possono rafforzare l’immagine del proprio brand, non più esclusivamente attraverso la comunicazione convenzionalmente visiva, quanto piuttosto con un’immagine multi-sensoriale, memorabile e coinvolgente. Peraltro, l’utilizzo combinato delle tecniche avanzate di neuromarketing e consumer science rende più semplice l’esplorazione delle risposte emotive e cognitive del nostro cervello nel momento della scelta di consumo.
Nel vostro Centro italiano di analisi sensoriali fate uso di queste tecniche?
Nella nostra sede a Matelica sono state sperimentate delle tecniche di sensory branding utilizzando gli strumenti della neuroscienza per correlare le emozioni e le funzioni cognitive nel consumo del caffè. Attraverso la rilevazione elettroncefalografica (EEG) è stato analizzato il valore che gli individui attribuiscono ad una determinata tipologia di caffè sulla base delle informazioni che hanno a disposizione. I partecipanti al test sono stati scelti tra i Coffe Lovers, soggetti che amano il caffè e che quindi hanno una maggiore consapevolezza del prodotto. La prova è stata divisa in tre fasi: nella prima, i partecipanti hanno valutato il prodotto senza nessuna indicazione (blind), nella seconda fase sono state valutate solo le informazioni legate all’origine e alla varietà (expected), e nella terza fase è stato sottoposto a giudizio il prodotto corredato di informazioni (labelled). I campioni sono stati randomizzati, cioè assegnati con metodo casuale, e codificati differentemente in ogni fase.
Cos’è emerso?
Il test ha evidenziato che le informazioni influenzano la valenza emotiva rispetto ai prodotti. Il prodotto che in realtà ha suscitato maggiori emozioni positive nella fase blind, non ha avuto lo stesso successo durante la fase expected.
È dimostrato quindi che stimolando i cinque sensi per suscitare emozioni e creare esperienze si possono generare nuove aspettative utili a differenziare il proprio brand e fidelizzare i clienti. © (riproduzione riservata)
(Articolo scritto per Espresso Ideas by Simonelli Group, pubblicato sul n. 15/16, novembre 2015)

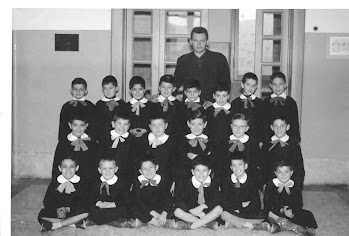


Commenti
Posta un commento