Dieci "penne" vittime della Grande Guerra
© La storia del giornalismo italiano è fatta di grandi giornali e di famosi giornalisti, ma anche di tante “gazzette” di provincia e di coloro che le hanno fondate, dirette o che vi hanno collaborato con passione.
Uno dei periodi più fecondi, per grandi e piccoli giornali, è stato sicuramente quello compreso tra l’epoca post unitaria e i primi anni del ‘900, fino alla prima guerra mondiale. In quegli anni nascono i grandi giornali nazionali (Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Resto del Carlino) e sorgono ovunque fogli locali che vedono in prima linea tanti giovani intellettuali.
Circoli ed associazioni della stampa si costituiscono un po’ ovunque e in quegli anni – 1908 per l’esattezza – nasce la Federazione nazionale della stampa italiana.
Quello locale è un giornalismo soprattutto di opinione, impegnato su questioni politiche e sociali. Nonostante il paese presentasse profonde fette di analfabetismo, i giornali furono un insostituibile mezzo di circolazione delle idee e il movimento a favore dell’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale trovò una spinta decisiva anche nell’azione che molti giornali esercitarono sull’opinione pubblica.
La Grande Guerra, così chiamata sin dai primi momenti per le inedite dimensioni del conflitto e per le modalità strategiche delle operazioni militari, fu in un certo senso anche la prima guerra “mediatica”. Non tanto nel significato che il termine ha assunto oggi, quanto per il fatto che i nuovi mezzi di comunicazione dell’epoca ebbero un loro ruolo (si pensi alla fotografia) durante, ma ancor prima che la guerra scoppiasse. Molti giornalisti, sostenitore del movimento interventista, furono tra i primi ad arruolarsi volontari e tra loro anche alcuni marchigiani che caddero in combattimento o a seguito delle ferite riportate.
***
Il nome più conosciuto è quello di Filippo Corridoni, noto a tutti come sindacalista nella Milano del primo ‘900, il quale fu anche giornalista. Nato a Pausola (oggi Corridonia) il 19 agosto 1887, all’età di vent’anni fondò un giornale antimilitarista, “Rompete le righe” e successivamente “Bandiera Rossa”, che ebbe vita breve. Collaborò attivamente con altre testate: La Conquista, Bandiera Proletaria e Bandiera del Popolo. Per le sue battaglie sindacali ottenne l’appoggio di Mussolini che all’epoca era direttore de’ L’Avanti e nel 1914, allo scoppio della guerra, Corridoni ebbe una “conversione” a favore del movimento interventista, ritenendo che da una sconfitta della Germania e dell’Austria-Ungheria si potessero “aprire grandi opportunità per costruire su nuove basi economiche e sociali, ma soprattutto morali, una rivoluzione sociale”. Nel maggio 1915 Corridoni si presentò volontario, ma a causa del suo cagionevole stato di salute venne assegnato alle retrovie. Dopo molte insistenze riuscì ad essere inviato al fronte, partecipando ai combattimenti sul Carso. Il 23 ottobre 1915, in un’offensiva per la conquista di un avamposto nemico, fu colpito a morte e il suo corpo risulterà disperso.
Tra i marchigiani caduti nella “Grande guerra” figurano anche due giornalisti che con i parametri di oggi potremmo definire “professionisti”, in quanto dediti in modo esclusivo all’attività giornalistica: Amilcare Mazzini, nato a Mondolfo il 22 maggio 1894 e Gaetano Serrani, nato a Tolentino il 6 novembre 1882.
Amilcare Mazzini, figlio d’arte (suo padre Pietro era stato direttore de “Il Caffaro” di Genova), lavorò per La Stampa di Torino, che lo assunse come corrispondente da Parigi. Scrisse di sport per la Stampa sportiva ed anche per La Gazzetta dello Sport. Partì volontario per la Grande Guerra e combatté come ufficiale del 1° Reggimento Granatieri. Morì a Treschè Conca (Asiago) il 30 maggio 1916, colpito alla testa da una pallottola di fucile austriaco. Dettero notizia della sua morte La Stampa, L’Illustrazione della Guerra e la Stampa Sportiva. Il suo nome comparve sulla copertina de La Guerra Italiana del 15 ottobre 1916.
Gaetano Serrani lasciò le Marche all’età di 21 anni per iniziare l’attività giornalistica. Nel 1914 era inviato de’ Il Resto del Carlino ed in tale veste intervistò Benito Mussolini, all’epoca direttore de’ L’Avanti. Tra i due nacque un’amicizia anche politica, tant’è che quando Mussolini, per dare voce all’area interventista del Partito socialista, fondò a Milano Il Popolo d’Italia, Serrani fu a suo fianco come principale redattore. Arruolatosi come sottotenente del 29° Reggimento fanteria, “Brigata Pisa”, morì il 17 marzo 1917 a seguito delle ferite riportate in un’azione bellica, lasciando orfani cinque figli, tutti in tenera età. Le sue spoglie sono sepolte nel Sacrario militare di Redipuglia.
I nomi di Mazzini e Serrani figuravano tra quelli scolpiti – 83 in tutto – nella lapide “In memoria dei giornalisti morti per la Patria, 1915-1918” ritrovata casualmente nel 2011, dopo oltre mezzo secolo da quando se ne erano perse le tracce, negli scantinati di un palazzo romano. Quella lapide era stata posta nel 1934 nell’atrio del Circolo della Stampa di Roma ed il suo casuale ritrovamento ha destato la curiosità storica di Pierluigi Roesler Franz, a lungo firma del Corriere della Sera e de’ La Stampa, il quale approfondendo le ricerche ha individuato ben 264 giornalisti italiani caduti durante la prima guerra mondiale. Tutti i loro nomi sono ora ricordati in un libro, “Martiri di carta”, di cui sono autori lo stesso Franz e lo storico Enrico Serventi Longhi, pubblicato dall’editore Gaspari di Udine per conto della Fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi”.
***
L’appassionato lavoro di Pierluigi Franz ha portato alla luce i nomi di altri giornalisti marchigiani e permesso di riscoprirne alcuni già conosciuti agli storici locali, come ad esempio il maceratese Arturo Mugnoz, al quale Marco Severini, Alessandra Fermani e Laura Montesi hanno dedicato un libro edito da Affinità elettive.
Per Arturo Mugnoz (nato a Macerata il 3 agosto 1889) il giornalismo fu lo strumento per il proprio impegno intellettuale e politico, tanto che la parte più interessante della sua biografia si racchiude proprio nell’attività giornalistica condotta nell’arco di poco più di un quinquennio, fino al suo arruolamento. Le due “creature” di Mugnoz furono L’Energia, quindicinale fondato nel 1910 e La Preparazione, settimanale edito a partire dal 1913. Collaborò anche al Fieramosca di Firenze, distaccandosi progressivamente dalle posizioni prezzoliniane, e seguì un gruppo di dissidenti che, guidati da Gaetano Salvemini, confluirono nel primo comitato redazionale dell’Unità. Sempre a Firenze contribuì alla nascita del foglio Risorgimento. Chiamato alle armi, raggiunse il fronte nell’ottobre 1916 e con il grado di sottotenente partecipò ai combattimenti tra l’Isonzo e il Carso. Il 28 maggio 1917 rimase gravemente ferito e morì a Villa Vicentina il 22 giugno 1917. Dopo la seconda guerra mondiale le sue spoglie sono state traslate nel cimitero di Treia, nella tomba della famiglia Mugnoz-Speranza.
Il contributo di sangue offerto dalle Marche nella Grande Guerra annovera anche un giornalista caduto prima ancora dell’ingresso dell’Italia nel conflitto. È l’anconetano Lamberto Duranti, il quale nel 1914 si arruolò volontario nella Legione Garibaldina che operava nella regione francese delle Argonne. Il 5 gennaio 1915, nei pressi di La Harazee, fu colpito al cuore e morì nella trincea di Four de Paris. I suoi resti riposano nel cimitero di Tavernelle del capoluogo dorico. Come giornalista Duranti, che era nato il 21 gennaio 1890, collaborò assiduamente al Lucifero, noto giornale di Ancona e in seguito entrò nella redazione romana de’ La Ragione. Successivamente fu redattore de’ La Luce repubblicana, La Libertà di Ravenna, La Provincia Romana e Il Popolo di Perugia. Inviava resoconti anche dal fronte, tant’è che il giorno stesso della sua morte il giornale Il Secolo uscì con un suo servizio sulla battaglia di Bois de Bolante.
***
Altri giornalisti, che si annoverano tra i circa ventimila militari marchigiani caduti nelle Grande Guerra, sono: Augusto Agabiti, Alberico Bacciarello, Ennio Mancini, Manlio Marinelli, Eugenio Niccolai.
Augusto Agabiti, scrittore e critico letterario, interventista e repubblicano, fu direttore dal 1914 della rivista teosofica “Ultra” di cui era stato collaboratore sin dal 1907. Nato a Pesaro il 7 gennaio 1879, morì a Roma (dove si era trasferito con la famiglia) il 5 ottobre 1918 a seguito della "spagnola", malattia contratta dopo aver combattuto al fronte come tenente del 1° reggimento genio.
Alberico Bacciarello, nato ad Ancona il 16 settembre 1888, fu studioso del rapporto tra arte e cattolicesimo, nonché redattore – oltre che cofondatore – de’ L'Italia Nostra, settimanale “neutralista” edito a Roma, le cui pubblicazioni furono sospese con l’entrata in guerra dell'Italia. Chiamato alle armi ed arruolato come sottotenente nel 34° reggimento Fanteria (Brigata Livorno), morì per le ferite riportate in combattimento a Monte Sabotino il 24 ottobre 1915 e fu sepolto nel cimitero di quella stessa località.
Ennio Mancini, nato a Iesi il 21 febbraio 1889, era figlio di un garibaldino e collaboratore della testata “Apostolato Mazziniano”, organo del Partito Mazziniano Italiano Intransigente, per un certo tempo stampato a Jesi. Scrisse l’opera “Storia del Partito Mazziniano Italiano Intransigente dal congresso di Roma del 1908 a tutto il 1912”, dove rivelò non solo la vicenda storica del Partito, ma anche i contrasti e le scissioni che ne caratterizzarono l’esistenza. Soldato del 77° Reggimento Fanteria Brigata Toscana, morì travolto dalla furia delle acque del Brenta, mentre si trovava al fronte con le truppe italiane che si stavano riorganizzando per arrestare l’avanzata del nemico. Il suo corpo venne recuperato dopo tre giorni di ricerche. Sepolto a Bassano del Grappa, le sue spoglie furono in seguito tumulate a Iesi.
Manlio Marinelli, nato ad Ancona il 20 novembre 1886, era fratello di Oddo, noto repubblicano, direttore de La Giovine Italia. Fu professore di italiano e a soli 26 anni già Direttore di una scuola a Forlimpopoli. Scrisse apprezzati saggi sulle opere di Pascoli, Carducci e Leopardi. Come giornalista diede sostegno a tutte le iniziative editoriali del fratello firmandosi con lo pseudonimo Stelio De Luca. Prese parte alla Grande Guerra come capitano del 121° Reggimento Fanteria, Brigata Macerata. Morì in combattimento a Castelnuovo sul Carso, tra il 27 e il 28 novembre 1915 e il suo corpo andò disperso.
Eugenio Niccolai nacque a Pausola (Corridonia) il 13 luglio 1895. Studente di giurisprudenza, si impegnò nel movimento nazionalista e si dedicò al giornalismo. Fece il corrispondente per L'Ordine, nonché de’ Il Resto del Carlino. A Macerata fu tra i fondatori dell'Associazione della Stampa (alla quale era iscritto anche Mugnoz), diventandone segretario. Allo scoppio della guerra si arruolò e, dopo aver frequentato la Regia Scuola di Fanteria, venne nominato sottotenente e assegnato al 151° Reggimento della Brigata “Sassari”. Promosso tenente e poi capitano di complemento, il 31 gennaio 1918, mentre già ferito guidava i suoi soldati, fu colpito a morte. Il suo corpo fu recuperato solamente il giorno successivo e tumulato in un cimitero da campo. Nel 1924 l’Università di Macerata gli conferì la laurea ad honorem post mortem e in quello stesso anno la sua salma fu traslata nella monumentale tomba di famiglia a Macerata.
Dopo la fine del conflitto, Niccolai e il suo concittadino Filippo Corridoni sono stati insigniti della medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Medaglie d’argento alla memoria sono state conferite ad Alberico Bacciarello e ad Amilcare Mazzini. Nel 1921 è stata assegnata la Croce al merito di guerra ad Arturo Mugnoz. Il sacrificio di Corridoni e di Gaetano Serrani fu pubblicamente ricordato da Mussolini in un famoso discorso nel marzo 1919 a San Sepolcro. A Serrani, inoltre, fu dedicata una commemorazione ufficiale nel 1935 nella sua Tolentino, mentre Milano gli ha dedicato una via nel quartiere Greco, nel cosiddetto Villaggio dei giornalisti.
Nella foto, da sinistra verso destra: Filippo Corridoni, Eugenio Niccolai, Arturo Mugnoz e Augusto Serrani.
(articolo scritto per Le Cento Città e pubblicato sul n. 65 - dicembre 2018)

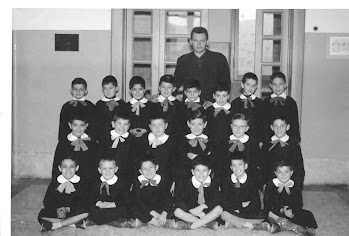


Commenti
Posta un commento