Bauhaus, 100 anni di stile e praticità
© Immaginate di rimanere particolarmente attratti da una macchina per caffè che vi colpisce per il suo fascino estetico. Nel vederla già ve la immaginate sul bancone del vostro locale e, in effetti, dopo averla acquistata essa dà nuova luce a tutto il vostro esercizio e colpisce l’attenzione di ogni cliente. Vi accorgete, però, che l’espresso preparato con questa macchina non è all’altezza delle vostre aspettative e soprattutto non è all’altezza del palato esigente degli avventori del vostro locale. Cosa fare allora? Cambiarla, con il rischio di deludere i clienti che hanno già familiarizzato con quella splendida macchina sul bancone? No, decidete di tenerla, ma nello stesso tempo ne acquistate una nuova, perfetta sul piano delle prestazioni, ma non altrettanto bella da vedere. Questa seconda la terrete nascosta dalla vista dei clienti, i quali - mentre continueranno ad ammirare la macchina in bella mostra sul bancone - gusteranno l’espresso preparato con la macchina “inguardabile”.
Una storia assurda, direte. In effetti è un paradosso. Oggi sappiano tutti che una simile circostanza raramente accade, ma se dimentichiamo per un attimo le macchine per caffè e andiamo molto indietro nel tempo, addirittura nel periodo della cosiddetta “rivoluzione industriale”, quando il progresso scientifico e tecnologico prese il sopravvento dando vita alla produzione di manufatti in serie, la storia che abbiamo ipotizzato poteva verificarsi assai di frequente.
La ventata di modernità dell'Ottocento portò a privilegiare le scoperte scientifico-tecnologiche, originando profonde trasformazioni nei modi di produzione che pose spesso in secondo piano l’aspetto estetico, nonostante in quello stesso periodo fiorissero anche nuovi ed importanti movimenti artistici. L’arte e l’industria erano due mondi che si trovarono a dover convivere. Nasce così il concetto di “arte applicata” in contrapposizione all’arte “tout court” e all’artigianato. Si aprono le porte a temi e dibattiti via via più evoluti, come ad esempio il nesso tra “utile e bello” e si gettano le basi del disegno industriale fino ad arrivare alla più ampia idea di design, che sin dalla sua origine si è posto il dilemma del ruolo dell’ornamento rispetto ai prodotti industriali, ma soprattutto la grande questione centrale: il rapporto tra forma e funzione, su cui si è poi innescato anche il moderno concetto di ergonomia.
Questo dibattito trova terreno particolarmente fertile in Germania. Subito dopo la prima guerra mondiale il sistema industriale tedesco, sviluppatosi in modo impetuoso, si trovò a dover convivere con radicali riforme economico-sociali e tale movimento di integrazione ebbe un immediato riflesso sui luoghi di lavoro. Sorsero nuovi stabilimenti dove i progettisti, come Adolf Meyer e Walter Gropius, cercarono di far convivere le esigenze della produzione con una nuova qualità della vita e delle attività richieste agli operai. È quindi dalla architettura industriale che prende corpo un progetto di riforma culturale e civile che in pochi anni coinvolge il sistema produttivo e il mondo delle arti. Peter Behrens, progettista per l’AEG, iniziò a sostenere che “in tutti gli oggetti prodotti in modo meccanico non bisognerebbe cercare di realizzare un contatto superficiale fra l’arte e l’industria, ma l’intima unione di entrambe”. Una tesi che trova subito sostenitori in una vasta platea di progettisti, designer, artisti e nel 1919 a Weimar, dalla fusione della locale Scuola d’Arte applicata con l’Istituto superiore di Belle Arti, per volontà del suo primo direttore Walter Gropius, nasce la Bauhaus (casa della costruzione).
Il “manifesto” e il programma vengono pubblicati da Gropius in un documento che in copertina riporta la xilografia di Lyonel Feininger dal titolo “Cattedrale”, a simboleggiare l’incontro linguistico ed operativo di pittura, scultura e architettura. “Bauhaus – ha scritto Giordano Pierlorenzi, direttore di Poliarte - nasce per unire, affratellare, integrare le diverse espressioni comunicative e progettuali, ma anche affrancare ed elevare le arti più umili, quelle applicate, portandole alla pari dignità. Si vuol finalmente superare l’odiosa divisione tra arti nobili e arti applicate, liberali e servili. Qui si rinnova il prodigio della “fabbrica classica”, della “bottega rinascimentale”, della “accademia sei-settecentesca” in cui si possono vedere insieme al lavoro studenti, docenti, artigiani, artisti, architetti, che sperimentano l’opera d’arte totale. Gli studenti nella scuola di Weimar crescono contemporaneamente come uomini e progettisti, consapevoli che il progetto è la risposta ad un bisogno da soddisfare, ad un problema da risolvere con il piacere della ricerca artistica ed il rigore del metodo tecnico-scientifico. Nella Bauhaus il design non è più un sostantivo astratto ma il significato provato di un processo progettuale in cui la creatività e la tecnica si integrano e il pensiero e l’azione trovano unità”.
Per lo storico dell’arte Roberto Cresti, curatore di una mostra allestita all’Università di Macerata, il Bauhaus fu una “comunità produttiva” fin dalla sua fase embrionale, particolarmente ricca di spunti. I primi prototipi vennero proposti alle industrie tedesche e già allora Marcel Breur poté elaborare uno stile che avrebbe rivoluzionato l’arredamento. Altri designer non risultarono da meno in altri settori. Artisti come Kandinskij e Klee disegnarono materiali da cui sarebbe sorta una nuova grafica pubblicitaria. Nella nuova sede, dopo il trasferimento da Weimar a Dessau, i laboratori del Bauhaus assunsero la funzionalità di “vere officine e l’artista-artigiano divenne un operaio-costruttore in grado di utilizzare strumenti sofisticati e materiali di alta qualità”.
Fu in questa fase che “il punto di partenza di ogni progetto era rappresentato dall’intuizione unitaria della forma. La progettazione doveva tener conto di esigenze vitali e materiali a cui dare una configurazione che ne rispettasse prerogative e necessità”.
La grande modernità e la rivoluzionaria portata del Bauhaus, che sono sopravvissute alla scuola stessa e che sono ancora oggi il fulcro del design sta nel concetto stesso di forma. “La forma stessa – ha scritto Roberto Cresti in occasione della mostra per il centenario – aveva il carattere di un principio di armonia mentale che assumeva gli elementi del mondo esterno al proprio interno: CONCETTO + VITA + FUNZIONE = FORMA”.
L’istituto d’arte e mestieri Bauhaus, che negli anni Venti del ‘900 divenne uno dei maggiori centri del design in Germania e nel mondo, ebbe però vita breve a causa dell’avvento del nazismo che, nel 1933, dopo un ulteriore trasferimento della sede a Berlino, lo condannò alla chiusura definitiva. Ma lo spirito della scuola non morì. L’eco del Bauhaus, che aveva già valicato i confini delle Germania, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, a cominciare dall’America dove Gropius, Breuer ed altri loro colleghi andarono ad insegnare nelle maggiori università degli Stati Uniti.
La filosofia di fondo del Bauhaus, cioè creare oggetti belli e funzionali, alla portata di tutti, puntando ad unificare arte e tecnologia per vincere le sfide e le esigenze della produzione di massa, non si è estinta, ma si è diffusa e moltiplicata contaminando anche altri movimenti e ancora oggi è più che mai vitale.
Gli insegnamenti del Bauhaus e la loro attualità
Le tante iniziative in programma nel 2019 in Europa e nel mondo per celebrare il primo centenario del Bauhaus dimostrano come i suoi insegnamenti siano ancora oggi attuali nel design contemporaneo e soprattutto che siano destinati a non morire.
La forma segue la funzione
Era questa una delle idee fondamentali del Bauhaus. Essa vuole dire che nel design una forma deve essere sempre applicata per via della sua funzione piuttosto che del suo fascino estetico e che l’utilità del manufatto è l’elemento prioritario da considerare nella progettazione.
Stile minimalista e materiali veri
Lo stile minimalista del design Bauhaus riflette le idee di funzionalità, così come i materiali devono far emergere la vera natura degli oggetti. Privilegiare quindi le forme lineari e geometriche, senza nascondere i materiali per amor dell’estetica. I metalli come il legno sono semplicemente parte integrante del progetto e le uniche cose importanti sono la linea, la forma e i colori. Tutto il resto non è necessario e può quindi essere ridotto all’osso.
Unione di arte e tecnologia
Nel 1923, il Bauhaus organizzò una mostra intitolata “Art & Technology: A New Unity” per sottolineare l’importanza da dare al concetto di tecnologia. Nei laboratori del Bauhaus si iniziò a sviluppare prototipi di prodotti adatti alla produzione di massa e tipici dell’epoca. Anche gli artisti erano ben felici di accogliere le nuove possibilità delle moderne tecnologie.
Gli iconici oggetti Bauhaus
Il Bauhaus è stato quindi un movimento rivoluzionario, che ha modificato per sempre il volto del design, oltre che dell’arte e dell’architettura. Gli oggetti Bauhaus sono importanti pezzi di storia dell’arte ancora oggi sorprendentemente contemporanei e richiesti dal mercato. Dalla famosa sedia Wassily di Marcel Breuer alla poltrona Barcelona di Ludwig Mies van Der Rohe, dalla Scacchiera di Josef Hartwig all’iconica Lampada Mt8 di William Wagenfeld e Carl Jakob Jucker. Ed ancora, la maniglia di Walter Gropius, i colorati tavolini ad incastro di Josef Albers, il servizio da tè e caffè di Marianne Brandt.
Tutti questi oggetti d’uso quotidiano rappresentano la fusione ideale tra creatività e produzione industriale e il perfetto raggiungimento dell’obiettivo del Bauhaus: “conciliare la componente tecnica e funzionale di un oggetto con la sua valenza estetica”.
Bellezza e praticità, quindi, un concetto oggi essenziale nel design e che rende quanto mai attuale l’insegnamento del Bauhaus.
Questa eredità del Bauhaus costituisce da sempre la filosofia progettuale della Simonelli, che, proprio per il ricercato equilibrio fra estetica e funzionalità, la portò, nel 2003, con la Aurelia, ad introdurre il concetto di ergonomia nel mondo delle macchine da caffè. È stata quindi una Simonelli la prima macchina al mondo ergonomicamente certificata ed oggi le iconiche linee della Black Eagle, del Mythos, della nuova Eagle One, così come della Aurelia Wave possono essere considerati emblemi contemporanei della gloriosa scuola di design. Con queste macchine nessun barista si troverà mai a vivere il paradosso con cui abbiamo introdotto questo articolo.
(articolo scritto per Espresso Ideas by Simonelli Group, pubblicato sul n. 22 - novembre 2019)

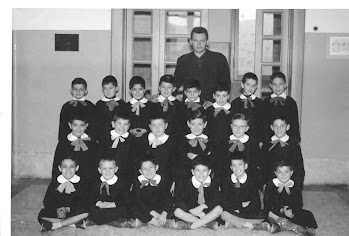


Commenti
Posta un commento