Albert Einstein. La scienza, un continuo conflitto di meraviglie.
Illustrazione di Claudia Palmarucci per Espresso Ideas
(Questo articolo è stato scritto per Espresso Ideas by Simonelli Group, pubblicato sul n. 17-18, novembre 2016)
“È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione”. Quando Albert Einstein pronunciò questa frase forse non credeva fino in fondo di poter aver ragione riguardo la sua teoria della “Relatività Generale”. O meglio, lui ne era convinto, ma non aveva potuto dimostrarlo. La dimostrazione di quella sua teoria, sogno di generazioni di fisici che hanno seguito le orme del grande scienziato, si è infatti avverata proprio cento anni dopo la pubblicazione di quelle formule, avvenuta nella primavera del 1916 sugli “Annalen der Physik”, dopo che – nel novembre dell'anno precedente – erano state presentate davanti all'Accademia prussiana delle Scienze.
Ma cosa è avvenuto a un secolo di distanza dalla pubblicazione della teoria della “Relatività Generale”? C’è stata la prova della validità di quanto Einsten aveva “scoperto”. A rendersene conto sono stati gli astrofisici di due centri di ricerca americani, Livington e Hanford, distanti tra loro tremila chilometri. Nel primo impianto, fra i raggi laser che corrono cento volte al secondo su due tunnel lunghi quattro chilometri e messi ad angolo retto, si è creato un piccolissimo segnale di sfasamento. Appena venti millisecondi dopo lo stesso fenomeno si è ripetuto, nell’impianto gemello, dall’altra parte degli Stati Uniti d’America. È stata la dimostrazione dell’esistenza delle onde gravitazionali.
Per provare a immaginare cosa sono le onde gravitazionali – ha scritto in un commento l’astrofisico italiano Leopoldo Benacchio – occorre fare uno sforzo mentale per disfarsi dell’idea di spazio e di tempo che tutti noi abbiamo in base al cosiddetto “senso comune”.
Se gli studi di Copernico e di Galileo non ci avessero dimostrato che è la Terra a girare attorno al Sole, in base al nostro “senso comune” ancora oggi saremmo portati a sostenere il contrario. Del resto se ci dovessimo basare esclusivamente sulla nostra percezione, sarebbe proprio la terra, dove noi camminiamo, a stare ferma. Il sole che sorge all’orizzonte al mattino, infatti, lo vediamo “salire” pian piano fin sopra le nostre teste, per poi scendere, altrettanto dolcemente, fino a scomparire all’orizzonte opposto. Anche il concetto di spazio in astrofisica non è quello che noi tutti intendiamo: un cassetto della scrivania, una stanza della casa, il rettangolo di un campo di calcio. E la stessa cosa si può dire per il concetto di tempo.
La teoria della Relatività
Con questa nuova teoria Albert Einstein allargava alla geometria e al principio di gravità i risultati dei suoi precedenti studi della cosiddetta “Relatività Ristretta” da lui raggiunti dieci anni prima e che avevano messo definitivamente in crisi i cardini allora dominanti della fisica, unificando i due tradizionali concetti fisici di spazio e di tempo in un unico concetto “spazio-temporale”.
Spazio, tempo e movimento sono gli elementi studiati e alla base del principio di relatività, ma tutto va posto “in riferimento a”. Così anche il concetto di velocità va correttamente espresso “rispetto ad un certo sistema di riferimento”.
Daniel F. Styer, professore di fisica all’Oberlin College in Ohio, nel suo libro “Relativity for the questioning mind”, cosi descrive il principio di relatività. “Se un sistema di riferimento si muove con velocità uniforme rispetto a un altro, i due sistemi di equivalgono per l’osservazione della natura; esperimenti interni eseguiti in modo identico nei due riferimenti daranno risultati identici” e porta ad esempio un fenomeno che tutti abbiamo avuto modo di sperimentare stando a bordo di un treno fermo in stazione. Guardando fuori dal finestrino ad un tratto, involontariamente, abbiamo avuto la sensazione che il nostro treno si fosse messo in movimento, ma qualche istante dopo ci siamo accorti che a mettersi in moto non è stato il nostro vagone, bensì il treno che fino ad un momento prima era fermo nel binario accanto, diretto però nella direzione opposta alla nostra.
Il principio della “Relatività Ristretta” riguarda sistemi di riferimento che si muovono uno rispetto all’altro in maniera uniforme. “Se il moto non è uniforme – spiega il prof. Styer nel suo libro – cioè se include accelerazioni, rallentamenti o cambiamenti di direzione, nei due sistemi di riferimento esperimenti identici daranno risultati diversi”. La dimostrazione l’abbiamo nella vita di tutti i giorni. Se viaggiamo in automobile con un ciondolo appeso allo specchietto retrovisore, il ciondolo lo vediamo pendere in verticale durante il tragitto percorso a velocità costante. Se improvvisamente diamo una forte accelerazione, lo vediamo inclinarsi verso la parte posteriore dell’auto; al contrario se freniamo di scatto, il ciondolo andrà a sbattere contro il vetro anteriore dell’automobile. Per lo stesso principio della fisica, quando viaggiamo in aereo la hostess ci serve da bere solo quando il velivolo procede in quota e a velocità costante. Se ci versasse la bibita durante la fase di accelerazione per il decollo, il liquido anziché nel bicchiere finirebbe sulla nostra camicia.
Il riferimento a una o all’altra situazione, in fisica è definito “inerziale” o “non inerziale”. Nel primo caso siamo in presenza di sistemi di riferimento alla base della teoria di Einstein chiamata della “Relatività ristretta” al centro della quale figurano tre principi essenziali: la dilatazione del tempo, la contrazione delle lunghezze, la relatività della sincronizzazione. Sono principi di cui non ci rendiamo conto, ma con i quali abbiamo a che fare tutti i giorni. Un esempio è il sistema GPS (Global Positioning System) che ci permette, attraverso un ricevitore, di determinare la nostra posizione.
L’onda gravitazionale
Emanuele Vinassa de Regny, un pioniere nella comunicazione scientifica, scomparso alcuni anni fa, ricordava come applicando la teoria della relatività alle leggi della meccanica, Einstein giunse a dimostrare con la famosa formula E=mc2 l’equivalenza tra massa ed energia.
Partendo dal presupposto che le leggi della natura devono essere valide anche nei sistemi “non inerziali”, in seguito Einstein allargò la sua teoria anche ai sistemi dei riferimenti in moto qualsiasi, giungendo a due conclusioni: a) l’equivalenza tra “massa inerziale” (valutata rispetto all’inerzia) e “massa gravitazionale” (valutata rispetto alla gravitazione; b) lo spazio è curvo e la sua curvatura, punto per punto, dipende dalla presenza o meno di masse.
Questi studi, durati una decina d’anni, permisero ad Einstein, nonostante non avesse accesso a strumenti di laboratorio, di trovare la relazione tra la fisica e la geometria e stabilire che quel che noi percepiamo come “gravità” è una conseguenza del moto attraverso lo spazio-tempo. Più grande è la sua curvatura più forte è la gravità. Lo spazio-tempo nella visione dello scienziato tedesco è come un sottile telo di nylon che viene deformato dalle masse che su di esso si muovono. Quando una massa si muove il “telo di nylon” subisce una ondulazione, più o meno leggera. Proprio questa ondulazione, che viaggia per tutto il telo trasportando l’energia sviluppata dal movimento, è l’onda gravitazionale.
Questa relazione costituisce il cuore della teoria della “Relatività Generale” ed ha rivoluzionato il modo di guardare il mondo e fornito una spiegazione a fenomeni fino a quel momento inspiegabili, giungendo a predire l'esistenza dei Buchi Neri (regioni dello “spazio-tempo” con un campo gravitazionale talmente forte e intenso che nulla al suo interno può sfuggire all’esterno, nemmeno la luce) e di un Universo non statico, ma in espansione.
L’evento registrato nei due laboratori statunitensi di Livington e di Hanford è stato valutato corrispondente alla fusione di due buchi neri con una massa, ognuno, di circa trenta volte il sole, che si sono “abbracciati” a una velocità di centocinquantamila chilometri al secondo.
Perché sono passati cento anni prima che le onde gravitazionali previste da Einstein fossero sentite? L’astrofisico Leopoldo Benacchio ha spiegato che esse sono “debolissime, quasi il rumore di fondo dell’Universo” e in un suo articolo ha portato come esempio la voce di una bambina che canta in uno stadio gremito durante una partita. Difficile che possa essere sentita da chi non le sta vicino. “Ci voleva pertanto un evento mostruoso, come la fusione di due buchi neri, per creare un ‘urlo’ che arrivasse con sicurezza fino a noi, come è accaduto”.
Benché la nuova teoria riuscisse a spiegare fenomeni da tempo inspiegabili con le conoscenze dell’epoca, lo studio di Einstein non fu ben accolto dalla maggioranza degli scienziati suoi contemporanei, che lo osteggiarono apertamente. Tant’è che nel 1921, quando ad Alberto Einstein fu conferito il Premio Nobel per la fisica, nella motivazione del riconoscimento non fu fatto alcun cenno alla teoria della “Relatività Generale”.
Lo scetticismo con il quale la maggior parte degli scienziati accolse la teoria della “Relatività Generale” derivava essenzialmente dal fatto che essa si fondava su ragionamenti matematici ed analisi razionali di Einstein, non su esperimenti ed osservazioni.
Eppure la nuova teoria ebbe quasi subito conferma grazie alla scoperta dell’incurvamento dei raggi luminosi in prossimità di corpi celesti di massa elevata, come i pianeti. Nel 1919, inoltre, le predizioni di Einstein furono confermate dalle misurazioni effettuate dall'astrofisico inglese Arthur Eddington durante un’eclisse solare. A questo proposito, Gabriella Greison, nel suo libro “Dove nasce la nuova fisica”, riferisce un curioso aneddoto che ha per protagonisti Einstein e il fisico tedesco Max Planck, uno dei suoi maggiori detrattori, morto nel 1947. Di lui Einstein avrebbe detto: “Non capiva nulla di fisica, perché durante l’eclisse del 1919 è rimasto in piedi tutta la notte per vedere se fosse stata confermata la curvatura della luce dovuta al campo gravitazionale. Se avesse capito la teoria, avrebbe fatto come me, e sarebbe andato a dormire”.
Sta di fatto che la teoria della Relatività Generale ha ricevuto nel tempo ulteriori conferme ed è oggi pienamente accettata, tanto da costituire “il linguaggio di tutta la fisica moderna”. E a chi dovesse ancora essere scettico si può sempre rispondere con un’altra frase attribuita a Einstein: “La cosa più incomprensibile del mondo, è che sia comprensibile”.
(Questo articolo è stato scritto per Espresso Ideas by Simonelli Group, pubblicato sul n. 17-18, novembre 2016)

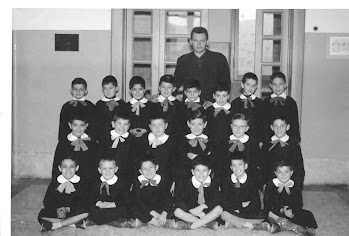


Commenti
Posta un commento