'Affiches' a caccia dei sensi
© Si parla sempre meno con le parole e sempre di più con le immagini. Tutti noi ricordiamo più a lungo ciò che abbiamo visto in TV rispetto a ciò che abbiamo ascoltato alla radio. Nei giornali e soprattutto nei magazine, i testi lasciano progressivamente spazio alle foto che molto spesso hanno la capacità di trasmettere la notizia con immediatezza ed effetto. L’arrivo di internet ci permette di vedere ciò che accade nell’altra parte del mondo stando comodamente seduti su una poltrona di casa e nello stesso modo scegliere il luogo della nostra prossima vacanza guardando e confrontando le immagini elettroniche. Anche se vogliamo cambiare la nostra automobile possiamo visitare virtualmente decine di autosaloni. Tutto questo si è moltiplicato da quando portiamo sempre con noi uno smartphone o un tablet, che usiamo anche per fotografare e condividere le immagini con gli altri. L’arrivo negli ultimi anni dei social network ci ha portato a comunicare sempre di più con meno parole e con molte immagini. Questa continua rivoluzione comunicativa è stata soprattutto vissuta in prima persona dalla pubblicità che, del resto, è l’espressione principe della comunicazione.
Siamo portati a credere che la pubblicità sia nata o cresciuta con i nuovi mezzi. Niente affatto. I nuovi mezzi hanno favorito i nuovi linguaggi e i nuovi modi di comunicare e, quindi, di fare pubblicità. È lo stesso effetto che ha provocato l’introduzione della posta elettronica. Oggi è stato calcolato che ogni giorno in tutto il mondo vengono inviate circa 250 miliardi di e-mail. Un numero sicuramente molto, ma molto più elevato di quello delle lettere che bisognava spedire quando si poteva usare solo carta e francobollo.
La pubblicità ha sempre avuto l’immagine come elemento principale. La pubblicità è nata con il sistema delle merci e per vendere le merci occorre farle vedere. Ma la pubblicità non ha solo lo scopo di mostrare; la pubblicità ha soprattutto l’effetto di emozionare e farci desiderare quel determinato cibo, quell’abito o non necessariamente un oggetto, ma anche un modo di vivere o semplicemente una vacanza. Era così anche prima di internet e della televisione. Anzi, l’immagine in pubblicità ha avuto un periodo d’oro proprio allora.
Se facciamo un salto all’indietro di un secolo, ci accorgiamo come la pubblicità abbia vissuto un momento di grande fascino proprio dall’inizio Belle Epoque, in cui comincia a nascere la società dei consumi, e poi per diversi decenni del XX secolo. Un periodo fortunato e abbastanza lungo.
Se oggi, usando anche gli strumenti della tecnologia più spinta, l’arte cinematografica e la fotografia la fanno da patrona nella pubblicità, nei primi decenni del secolo scorso altrettanta “contaminazione” si ebbe tra la pubblicità e le arti figurative.
Pubblicità e arte s’intrecciano in quegli anni in modo evidente che spesso diventa difficile considerare un aspetto tralasciando l’altro.
Siamo negli anni di un rinnovato vigore per il sistema produttivo e con la nuova industrializzazione aumentarono anche i consumi. In quel periodo nascono i grandi magazzini e l’industria alimentare. Entrano in produzione e distribuzione beni idonei a soddisfare bisogni, legati anche a un nuovo costume di vita. Sono quelli gli anni in cui si diffondono le prime automobili (nel 1888 J.B. Dunlop inventò lo pneumatico e nel 1909 la Ford introdusse la prima catena di montaggio per la produzione del mitico “modello T”, costruito in parecchi milioni di esemplari). Prendono piede la moda, le vacanze e i soggiorni termali e il caffè espresso. Nel 1905 nasce la Victoria Arduino. Pier Teresio Arduino, nel suo laboratorio di Torino, costruisce la sua prima macchina per caffè espresso. L’ingegner Arduino comprende che il mondo dei locali pubblici e delle caffetterie stava cambiando, e quindi le macchine in funzione negli stessi locali dovevano adeguarsi ai tempi, sia per concezione tecnica, sia per la loro estetica.
Per favorire la diffusione di questi nuovi beni di consumo occorre spingere sulla pubblicità e i produttori (Pier Teresio Arduino, come vedremo più avanti, non sarà da meno) fanno ricorso agli artisti loro contemporanei, i quali mettono a disposizione la loro arte, secondo i canoni del tempo. Sono gli anni dell’Art Nouveau e del Liberty, che influenzano la pubblicità, così come il design dei prodotti. Lo stesso sarà in seguito con il Futurismo.
A partire dagli anni a cavallo tra i due secoli nelle strade delle più grandi città, che si aprono all’era moderna, fanno la loro apparizione i primi manifesti pubblicitari, eccezionali strumenti di promozione del nascente consumismo. Prima di allora, i muri delle città erano spogli e le poche pubblicità che si potevano vedere erano quelle ideate per i quotidiani e i periodici, caratterizzate da una forte prevalenza del testo rispetto all'immagine. I centri cittadini, le stazioni ferroviarie e ogni luogo che rappresenti un centro economico o un punto di scambio e d’incontro, diviene il luogo ideale per comunicare, per creare i primi modelli sociali cui tendere, dialogando con un ceto sociale in grande trasformazione, desideroso di crescere, di conoscere e di consumare novità e prodotti.
I manifesti pubblicitari si diffondono rapidamente e negli anni ad essi si affiancheranno locandine, depliant, riviste illustrate. Tutto doveva informare il potenziale consumatore, catturandone l’attenzione, ma soprattutto lo doveva emozionare e farlo sentire protagonista. Chi guardava il manifesto doveva immedesimarsi nell’immagine raffigurata. Come ad esempio le signore che sono “invitate” a riflettersi nelle sognanti e misteriose dame proposte nei celebri manifesti dei Magazzini Mele di Napoli. Manifesti che diventano negli anni lo specchio nel quale si riflettono non solo la moda femminile, il taglio dei capelli, il linguaggio del corpo, ma anche i rapidissimi cambiamenti sociali ed economici, gli umori, le tendenze, i sogni.
La pubblicità assume un forte ruolo di informazione e di persuasione e i committenti si affidano al pennello dei più grandi illustratori dell’epoca, da Marcello Dudovich a Franz Lenhart, da Gino Boccasile a Duilio Cambellotti e Leonetto Cappiello, cui si deve il più famoso manifesto per la Victoria Arduino e del quale parleremo più avanti.
I manifesti, le locandine e le pagine delle riviste diventano quindi terreno privilegiato sul quale i migliori artisti, illustratori e figurinisti del periodo mettono la loro creatività al servizio di un genere solo apparentemente frivolo, sperimentando differenti approcci comunicativi e grafici e aggiornando continuamente il loro stile sulle tendenze figurative del momento.
La forza di comunicazione e penetrazione di questi manifesti sono affidate a immagini luminose, ridenti, sempre elegantissime, tanto per scelte cromatiche che per soluzioni formali.
È un periodo di grande fermento culturale, che spazia in Europa come negli Stati Uniti d’America, ma la sottile ironia, l’allusione, la fantasia sono caratteristiche che in quegli anni si ritrovano soprattutto nella comunicazione pubblicitaria italiana, confermando così la vitalità e la portata innovativa delle creatività italiana che in seguito esploderà in tutto quello che oggi va sotto il nome di Made in Italy.
Nel 1927, un’importante rivista internazionale, “Posters & Publicity” definisce il manifesto pubblicitario italiano “exciting”, nel senso che i loro autori catturavano l’attenzione dei passanti “con composizioni estremamente vivide, colorate, curiose, a volte esilaranti, tali da suscitare un interesse istintivo e legato ai sensi”.
Nel 1922, quando il nome Victoria Arduino è ormai conosciuto nel mondo, emblema del made in Italy di qualità e di bellezza, Pier Teresio Arduino commissiona all’artista e cartellonista Leonetto Cappiello (1875-1942) un’affiche pubblicitaria in cui si vede un elegante viaggiatore che, sporto da un treno in corsa, si prepara un espresso con la Victoria Arduino, divenuta ormai la macchina per caffè espresso in assoluto. L’artista in quell’immagine alludeva veramente ed efficacemente alla velocità con cui il caffè era preparato; l’eleganza del cliente era posta a raffronto con l’eleganza della macchina entrambi indicativi del modo di vivere moderno.
Assieme a Adolf Hohenstein, Giovanni Maria Mataloni, Leopoldo Metlicovitz e Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello è stato uno dei padri della moderna cartellonistica pubblicitaria italiano e il più innovativo del periodo. Egli è stato tra i più celebrati e seguiti artisti dell’affiche al quale in molti riconoscono la paternità del manifesto moderno. Un suo contemporaneo, il francese Mauzan, disse una volta: “I suoi manifesti si vedono da lontano”. I manifesti di Cappiello – e quello realizzato per Victoria Arduino ne è un esempio – catturano immediatamente l’attenzione del pubblico e rendono subito palese il significato. Cappiello era convinto che nel lavorare ad un manifesto pubblicitario l’artista dovesse frenare l’impulso verso “l’Art pour l’Art” , sforzandosi piuttosto a far coincidere due aspetti: quello artistico e quello commerciale. L’artista prediletto da Pier Teresio Arduino riteneva fondamentale che il manifesto fosse compreso da tutti con immediatezza e fu un assertore della funzione sociale dell’arte affidata al cartellone pubblicitario.
I manifesti stampati in Italia tra la fine dell'Ottocento e gli anni quaranta del Novecento sono frutto della fantasia di molti artisti, anche famosi e non solo italiani, tutti desiderosi di realizzare, in concomitanza con il crescere dell’industria e con il diffondersi dei consumi, un nuovo tipo di comunicazione, efficace, in linea con le ricerche figurative e grafiche del tempo.
Agli albori della comunicazione pubblicitaria, la loro opera apre un insolito spiraglio sul costume, sui “sogni” di modernità, sulle aspirazioni al benessere e a una migliore qualità della vita. Specchio di tendenze figurative che negli anni si sono modificate, il manifesto pubblicitario riflette modi di pensare e di rappresentarsi, che ci fa riflettere, ricordare, spesso sorridere, sempre con una chiave a volte bizzarra, a volte seducente, in grado di aprirci nuove strade nell'interpretazione della società e del nostro modo di vivere.
(questo articolo è stato scritto per Espresso Ideas ed è stato pubblicato sul n. 13-14 di ottobre 2014)

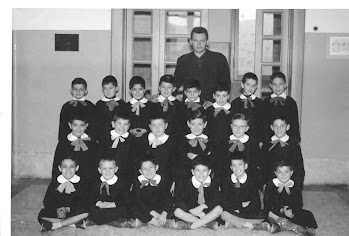


Commenti
Posta un commento